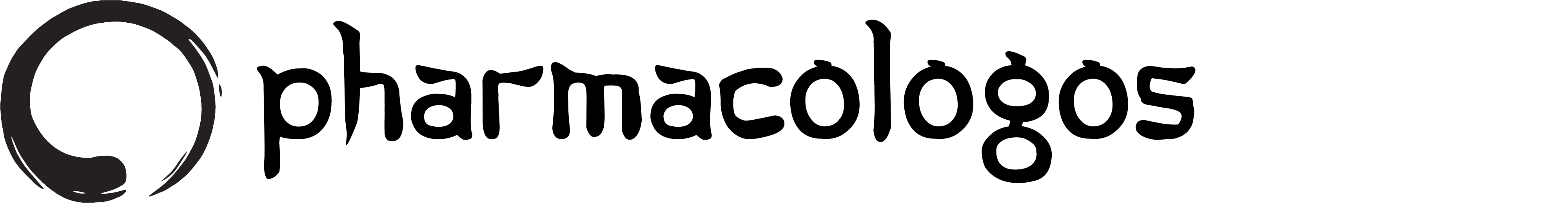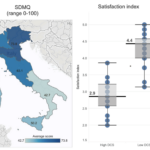Giuro per Apollo medico e Asclepio e Igea e Panacea e per gli dèi tutti e per tutte le dee, chiamandoli a testimoni, che eseguirò, secondo le forze e il mio giudizio, questo giuramento e questo impegno scritto.
Ippocrate di Cos (460 a.C – 377 a.C)
Igea, Panacea, Iaso, Aceso e Aegle.
Le figlie di Asclepio, insieme al padre erano dee della salute e della guarigione, ed impersonavano i diversi aspetti dell’attività medica. Le due gemelle minori Iaso (da ιάσθαι, “guarire”) e Aceso (da ακέομαι, “recuperare”), erano le dee della guarigione e del recupero dalle malattie. Erano spesso raffigurate con una benda e una spugna ed il loro compito era alleviare il dolore e le sofferenze dei pazienti. L’altra sorella minore, Aegle (da άιγλε, “splendore”), era la dea della luminosità e della bellezza del corpo sano. Era spesso raffigurata con una torcia o una corona di stelle e si occupava di restituire il vigore e un aspetto salutare ai pazienti guariti (Panagiotidou, 2016).
A rappresentare il nucleo della medicina erano però senza dubbio le due figlie maggiori di Asclepio, non a caso citate in apertura nel giuramento di Ippocrate:
- Panacea (Πανάκεια, “guarisce tutto”) era la dea del rimedio universale che poteva curare ogni tipo di malattia. Era spesso raffigurata con una corona di fiori e una ciotola di erbe medicinali con le quali si occupava di fornire le cure necessarie ai suoi pazienti. Veniva invocata per guarire da una malattia in corso.
- Igea (Υγίεια, “salute”) era la dea della prevenzione delle malattie e del mantenimento della buona salute. Era spesso raffigurata con una coppa e un serpente, ed affiancava regolarmente il padre in molti dei templi ad egli dedicati. Veniva invocata a protezione della salute dei suoi devoti, perché non si ammalassero.
Sono passati più di 1600 dai tempi di Ippocrate, e anche se il suo giuramento (pure se in versione modificata e aggiornata) viene ancora pronunciato dai medici neolaureati, la disciplina che oggi pratichiamo ha ben poco a vedere con quella di allora.
La Medicina ha infatti cambiato spesso statuto nei secoli, è stata considerata a volte arte, a volte tecnica, a volte pratica, a volte scienza, o un miscuglio di queste e altre cose. Ma tutto sommato si può ritenere che sia sempre stato il delicato equilibrio tra Igea e Panacea a definire quello che i medici hanno quotidianamente fatto, quello che fanno tutt’ora ed in fondo anche quello che la Medicina è.
Salute e malattia
Cos’è dunque questa Medicina? O, meglio, che genere di cosa è?
Intanto non è scontato sostenere che esista una sola Medicina, dal momento che in luoghi diversi ed in tempi diversi, diverse ‘medicine’ sono state e sono praticate. Anche se il paradigma oggi dominante, specialmente nei paesi occidentali, è quello della cosiddetta ‘biomedicina’, declinata soprattutto nella forma della Evidence Based Medicine (Vannacci, 2009), c’è da dire che fino a metà del XIX secolo, la pratica medica non si è discostata poi così tanto da quella dell’età classica. La medicina di Ippocrate e soprattutto quella di Galeno, con la sua teoria degli umori, ha dominato in tutta Europa per oltre un millennio, con pochissime modifiche apportate soprattutto durante il Medio Evo dai medici arabi, Avicenna in primis (Cruse, 1999).
È stato solo nel 1800 che la medicina ha cominciato a diventare più simile a come la intendiamo oggi, grazie in particolare al lavoro di Claude Bernard (1813-1878), il grande fisiologo francese a cui si deve l’introduzione del concetto di ‘omeostasi’, ma soprattutto una visione dell’organismo come “macchina uomo”. Bernard riteneva infatti che l’essere umano fosse un insieme di sistemi indipendenti che interagiscono tra loro, ognuno con un ruolo specifico nel mantenere in equilibrio la funzionalità complessiva dell’organismo (‘omeostasi’, appunto). Con lui per la prima volta il determinismo fa il suo ingresso nella medicina dalla porta principale, come “principio assoluto delle scienze sperimentali […] in fondo identico a quello delle scienze matematiche, perché sia nelle une che nelle altre questo criterio è espresso da un rapporto causale necessario e assoluto” (Bernard, 1865; in Canali, 2010). Una visione molto netta quindi, di una medicina come scienza naturale (fortemente sperimentale), caratterizzata da un continuum tra salute e malattia, regolato da leggi rigidamente deterministiche. Con qualche variazione, questo tipo di visione scientifica della medicina ha caratterizzato gli ultimi due secoli di storia, quantomeno in occidente, ed è ancora sicuramente molto forte.
Al centro di questo tipo di approccio troviamo il concetto di malattia. Sulla base di queste premesse di tipo naturalistico, negli anni ’80 del secolo scorso Christopher Boorse, opponendosi ad una visione normativista del concetto di salute, ha sostenuto una posizione secondo cui ogni organismo (o meglio, ogni apparato o sistema di ogni organismo) possiede una funzione che corrisponde ad un design naturale; quando il suo funzionamento è conforme a questo design, si ha la salute, quando devia, si ha la malattia (Boorse, 1982). In quest’ottica egli individua due definizioni di malattia: ‘disease’ (meglio ridefinita successivamente come ‘pathology’) e ‘illness’; il primo è un concetto teoretico, oggettivo, che descrive il malfunzionamento di un sistema in maniera pressoché indipendente dal soggetto che lo porta, il secondo è un concetto pratico, che descrive il fenomeno malattia dal punto di vista del soggetto che ne è affetto, è quindi normativo, e risente dei valori del singolo (Boorse, 1997). Al centro dell’approccio di Boorse c’è il concetto di pathology, che è nettamente intersoggettivo e si basa in fondo su un criterio statistico: la norma è la salute (l’aderenza al natural design), la deviazione statistica dalla norma è la patologia.
La biomedicina di oggi è ancora fortemente ancorata al concetto di pathology: il suo lavoro è ‘aggiustare una macchina che non funziona’; l’approccio è ultra-specialistico, il medico è una specie di super-meccanico, specializzato nell’aggiustare il sistema che non funziona e, a volte, non è più neanche tanto in grado di giudicare come funzionino gli altri sistemi. Per dirla con Ippocrate, la sua divinità guida è Panacea.
Esiste però un altro tipo di approccio alla medicina, secondo cui è molto più importante non ammalarsi, piuttosto che guarire da una malattia dopo averla presa. Al centro di questa visione troviamo il concetto di salute: il medico si prende cura del paziente in ottica soprattutto preventiva, con attenzione agli stili di vita, al benessere psico-fisico, e privilegia il rapporto empatico ed umano, rispetto al mero ruolo tecnico di curatore. Potremmo dire che la sua divinità guida è Igea.
Questo tipo di approccio, certamente non naturalista come quello di Boorse, è sostenuto da autori di area fenomenologica come Bill Fulford, i quali pongono al centro i valori del paziente, sostenendo che l’approccio naturalista può essere applicato in alcune aree tecniche della salute fisica, ma fallisce completamente in aree più complesse, come ad esempio i disturbi psichici (Fulford, 2001).
Se osservati ognuno per sé, i due approcci sembrano inconciliabili, due paradigmi incommensurabili. Ma in realtà non è così: la Medicina non è la ‘scienza sperimentale’ che credeva Claude Bernard, non è probabilmente neanche la disciplina basata strettamente sulla statistica proposta da Boorse, ma non è nemmeno una imprevedibile sequenza di singoli casi scollegati l’uno dall’altro.
In fondo non c’è niente di contraddittorio nel pensare che la Medicina sia fondamentalmente una scienza sociale, umana, che si basa sulle esperienze dei singoli, sui loro valori, sulla personale esperienza della sofferenza, le quali sono sì individuali, ma non arbitrarie: presentano infatti regolarità che si ripetono e sono aperte al controllo intersoggetivo dei risultati per mezzo della statistica (Buzzoni, 2022).
La tabella riassume schematicamente questi due approcci.
|
Panacea
|
Igea
|
|
| Modello di relazione | Intersoggettività | Soggettività |
| Disciplina di base | Statistica | Clinica |
| Centralità | Malattia (curarla) | Salute (mantenerla) |
| Concetto di malattia | Pathology | Illness |
| Modello di assistenza | Cure | Care |
I due approcci possono essere senz’altro integrati in una scienza sociale, ma è necessario un momento ermeneutico, per comprendere la malattia non solo come deviazione da una normalità fisica, ma anche come violazione di valori o obiettivi. Salute e malattia, infatti, non sono condizioni isolatamente oggettive, ma dipendono dai valori culturali e sociali, non catturabili unicamente attraverso l’analisi statistica (Buzzoni, 2003).
L’obiettivo della medicina come scienza sociale è molteplice e integrato: mantenere la salute finché c’è, prendendosi cura (care) dell’individuo umano, curare la malattia (cure) quando questa si manifesta, sia nel suo aspetto di pathology (utilizzando criteri diagnostici e strumenti terapeutici controllabili intersoggettivamente con strumenti statistici), sia nel suo aspetto fortemente soggettivo di illness, con attenzione ai valori del paziente ed ai significati che il disturbo ha per ogni singolo soggetto, considerato come individuo.
Questi aspetti non sono in contraddizione l’uno con l’altro; non solo è possibile, ma anzi è necessario integrarli, per garantire una medicina che sia da un lato scientifica e dall’altro umana. D’altra parte, è dai tempi di Ippocrate che Igea e Panacea si invocano insieme, insieme alle loro sorelle, al padre Asclepio ed al padre di lui Apollo medico.
È da questo punto di vista che è forse possibile dire che la Medicina è, ed è sempre stata, davvero Una.
Bibliografia
Boorse, C., 1997. A Rebuttal on Health, in: Humber, J.M., Almeder, R.F. (Eds.), What Is Disease?, Biomedical Ethics Reviews. Humana Press, Totowa, NJ, pp. 1–134. https://doi.org/10.1007/978-1-59259-451-1_1
Boorse, C., 1982. On the Distinction between Disease and Illness, in: Cohen, M. (Ed.), Medicine and Moral Philosophy. Princeton University Press, pp. 3–22. https://doi.org/10.1515/9781400853564.3
Buzzoni, M., 2022. Dalla valutazione clinica alla ricerca biomedica e ritorno: la medicina come scienza umana., in: Alici, L., Pierosara, S. (Eds.), Riduzionismo e Complessità: Ritrovare l’umano, Umanizzare La Cura. Aboca.
Buzzoni, M., 2003. On Medicine as a Human Science. Theor Med Bioeth 24, 79–94. https://doi.org/10.1023/A:1022942002711
Canali, S., 2010. La medicina scientifica, in: Pagnini, A. (Ed.), Filosofia Della Medicina: Epistemologia, Ontologia, Etica, Diritto, Frecce. Carocci, Roma.
Cruse, J.M., 1999. History of medicine: the metamorphosis of scientific medicine in the ever-present past. Am J Med Sci 318, 171–180. https://doi.org/10.1097/00000441-199909000-00012
Fulford, K.W.M., 2001. “What is (mental) disease?”: an open letter to Christopher Boorse. Journal of Medical Ethics 27, 80–85. https://doi.org/10.1136/jme.27.2.80
Panagiotidou, O., 2016. Asclepius’ Myths and Healing Narratives: Counter-Intuitive Concepts and Cultural Expectations. Open Library of Humanities 2, e6. https://doi.org/10.16995/olh.34
Vannacci, A., 2009. La metodologia della ricerca nelle medicine non convenzionali, in: Cipolla, C., Roberti Di Sarsina, Paolo. (Eds.), Le Peculiarità Sociali Delle Medicine Non Convenzionali. F. Angeli.