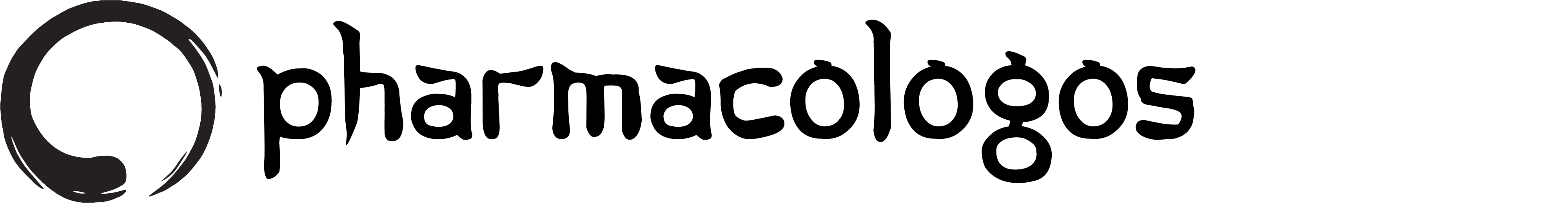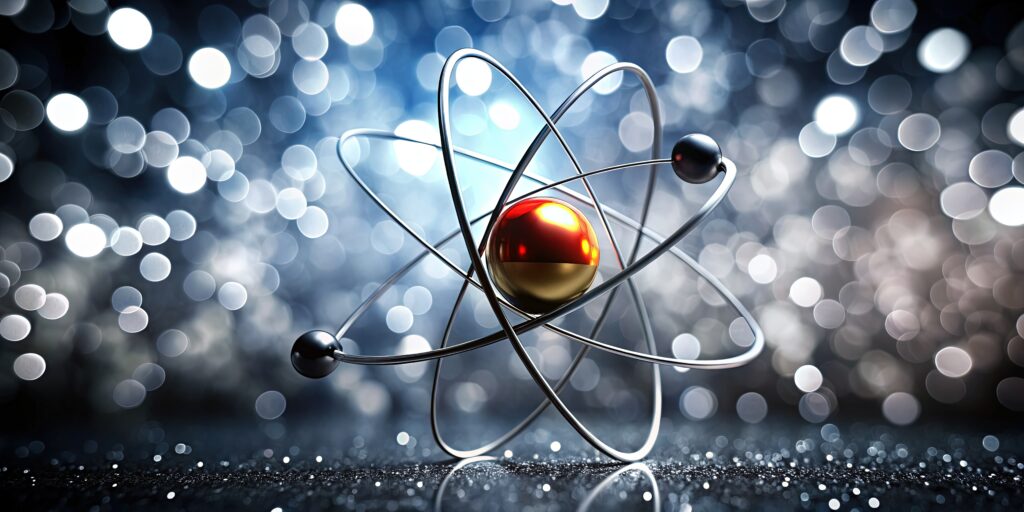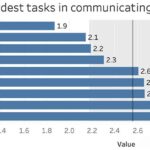Un ambito di notevole importanza nella storia della filosofia della scienza è da sempre rappresentato dalla diatriba tra realismo ed antirealismo scientifico. In questa area si possono individuare fondamentalmente due aree di discussione:
- quella relativa alla veridicità delle teorie scientifiche: cioè se queste siano una fedele descrizione di come in effetti funziona il mondo, oppure se siano legate a convenzioni di vario genere tra gli scienziati;
- quella relativa allo statuto ontologico degli enti inosservabili: cioè se i termini teorici presenti nelle varie teorie (es. ‘elettrone’, ‘atomo’, ‘gene’, ‘quark’ etc…) denotino entità realmente esistenti nel mondo, o siano invece soltanto postulati utili alla descrizione della realtà.
Realismo ed anti-realismo scientifico
Nella breve ma efficace definizione del realismo scientifico data da uno dei suoi più noti critici, secondo i realisti
“la scienza mira a fornirci, con le sue teorie, una storia letteralmente vera di ciò che è il mondo e l’accettazione di una teoria scientifica implica la credenza che essa sia vera” (Van Fraassen, 1985, p. 33).
Il realismo scientifico non può tuttavia essere considerato un concetto univoco della filosofia della scienza, ma è declinato in modo diverso a seconda della posizione di ciascun autore che la discute. Vi sono comunque diversi elementi comuni, in genere tenuti insieme da quello che può essere definito “un atteggiamento epistemicamente positivo verso i risultati dell’indagine scientifica, riguardo sia agli aspetti osservabili del mondo, sia a quelli non osservabili” (Chakravartty, 2017, p. 1).
In estrema sintesi, secondo l’approccio realista, gli asserti sulle entità inosservabili possiedono un valore di verità e le nostre migliori teorie scientifiche forniscono descrizioni vere o approssimativamente vere di aspetti osservabili e non osservabili di un mondo indipendente dalla mente.
In opposizione al realismo scientifico si pongono tutte quelle posizioni che oggi vengono accomunate sotto il nome di antirealismo scientifico, secondo cui la scienza è soltanto uno strumento affidabile per salvare i fenomeni e formulare previsioni sempre più precise, senza che ciò comporti qualcosa circa il modo in cui il mondo è in se stesso (Buzzoni, 2008, p. 169).
La forma più nota di antirealismo, sostenuto fin dai tempi del Circolo di Vienna da empiristi logici come Carnap, Hempel o Duhem (ma si può risalire sicuramente anche fino a Mach, il quale negava persino l’esistenza reale degli atomi), è il classico strumentalismo, secondo cui i termini inosservabili non hanno in sé alcun significato, non devono essere presi letteralmente come effettivo riferimento ad entità inosservabili, ma sono soltanto meri costrutti logici utilizzati come strumenti per sistematizzare le relazioni tra i fenomeni e consentire la anticipazione di esperienze sperimentali future (Chakravartty, 2017, p. 27; Ladyman, 2002, p. 155). Quindi, secondo gli antirealisti, gli asserti sugli enti inosservabili non possiedono un valore di verità, ma sono solo strumenti utili per salvare i fenomeni.
L’empirismo costruttivo e le sue critiche
Una posizione particolare ma di grande impatto nel campo dell’antirealismo è quella emersa negli anni ’80 del secolo scorso ad opera di Bas Van Fraassen, nota sotto il nome di ‘empirismo costruttivo’. Nell’opera ‘The Scientific Image’ il filosofo olandese ha proposto una sua versione della classica distinzione tra termini osservabili e termini teorici, in una forma molto particolare. L’empirismo costruttivo sostiene che la scienza non aspira a una verità completa, in senso letterale, ma soltanto ad una adeguatezza empirica: l’accettazione di una teoria scientifica implica soltanto la credenza che essa sia empiricamente adeguata (Van Fraassen, 1985, p. 37). L’empirista costruttivo si rifiuta di credere in qualunque cosa che vada al di là dei fenomeni osservabili e non riconosce alcuna modalità oggettiva in natura; la ricerca della verità è ristretta soltanto al mondo empirico e si occupa esclusivamente di ciò che è osservabile. Rispetto alla strumentalismo classico, l’empirista costruttivo riconosce però che le asserzioni intorno agli enti inosservabili possiedono un valore di verità: egli ritiene cioè che possano essere vere o false, ma assume un atteggiamento agnostico rispetto ad esse e non prende alcuna posizione né in un senso né nell’altro (Chakravartty, 2017, p. 28).
Un problema sollevato da alcuni critici è però che ogniqualvolta l’empirista costruttivo accetta una teoria, egli è autorizzato a credere solo alle affermazioni che riguardano entità osservabili, perché sulle altre è per definizione agnostico (Dicken and Lipton, 2006, p. 227). Quindi, per sapere a quali affermazioni di una teoria scientifica credere, egli ha bisogno di sapere quali affermazioni di quella teoria riguardano entità osservabili. Questo comporta, come evidenziato da Musgrave, che non tutte le affermazioni che è necessario accettare per la coerenza dell’empirismo sono affermazioni che possono effettivamente essere accettate dagli empiristi stessi (Musgrave, 1985, p. 1098). Dicken e Lipton portano avanti le osservazioni di Musgrave, mostrando con argomenti logici come la posizione dell’empirismo costruttivo sia in un certo senso circolare (anche se non necessariamente di una circolarità viziosa). Tuttavia, Muller e Van Fraassen fanno notare che tali obiezioni funzionano soltanto nell’ambito della cosiddetta ‘received view’, cioè di una concezione sintattica delle teorie scientifiche (Muller and Fraassen, 2008, p. 197). L’empirismo costruttivo invece, soprattutto a causa del concetto di ‘adeguatezza empirica’ intorno a cui questo approccio epistemologico si sviluppa, funziona esclusivamente nell’ambito di una concezione semantica delle teorie scientifiche.
Nelle parole di Van Fraassen, “l’approccio semantico non è così legato al linguaggio come lo è la visione sintattica: una teoria non è identificata tramite la sua formulazione in un linguaggio specifico (o un insieme di formulazioni in linguaggi specifici), bensì per mezzo di un insieme di modelli” (Muller and Fraassen, 2008, p. 201). La proposizione di un sistema centrato sui modelli consente agli empiristi costruttivi di aggirare l’ostacolo presentato dai loro critici (che si basa fondamentalmente su una questione formale) introducendo nella propria ‘policy epistemica’ una ‘regola 0’ nella quale in un certo senso ‘l’osservabilità precede l’esistenza’. Per dirla in termini logici, la quantificazione non è in questo caso ristretta al campo di ciò che effettivamente esiste (Muller and Fraassen, 2008, p. 203): se si accetta una teoria T la quale sostiene che un ente Y è inosservabile, allora l’empirista costruttivo è autorizzato a ritenere che tale ente, nel caso esista, sia inosservabile, ma non necessariamente che esso esista (Muller and Fraassen, 2008, p. 204).
Un approccio prospettivista alla questione degli enti inosservabili
Restando nel solco tracciato da Van Fraassen in relazione alla concezione semantica delle teorie scientifiche, una posizione interessante è quella del cosiddetto ‘prospettivismo scientifico’, proposto da Ronald Giere. Sviluppatasi a partire da una posizione realista, ma sensibile alle osservazioni di Van Fraassen[1], questa visione si pone come mediazione tra la posizione dei realisti oggettivi, che sostengono l’esistenza di una verità assoluta su come è fatto il mondo, e quella degli antirealisti, che ritengono che gli asserti scientifici siano solo convenzioni o costrutti sociali. Giere descrive questo approccio come un realismo moderato, che tiene conto sia delle critiche kuhniane, sia di quelle della sociologia della scienza, senza però aderire alle loro estremizzazioni. Tale approccio si applica sia al dibattito sui dati scientifici (e quindi agli enti inosservabili) sia a quello sullo statuto delle teorie scientifiche (Giere, 2006, p. 14).
Per quanto riguarda le teorie scientifiche, in estrema sintesi, Giere fa sue molte delle osservazioni di Nancy Cartwright e pone assai poca enfasi sul concetto di ‘legge’, diffidando delle generalizzazioni universali (Giere, 2006, p. 61). Egli presenta invece le teorie scientifiche come “costruzione e ragionamento intorno a modelli della realtà” (Giere, 1996, p. 130), ognuno dei quali consente di osservare il mondo secondo una specifica prospettiva e quindi di fare affermazioni valide soltanto in relazione a specifici aspetti della realtà, pertinenti per quel singolo modello (Giere, 2006, chap. 5).
Per quanto riguarda gli enti postulati dalle teorie, invece Giere adotta un approccio fondamentalmente realista, ma lo pone in una prospettiva costruttivista. Per descrivere questa posizione usa come esempio il fenomeno della visione dei colori: gli esseri umani percepiscono il mondo come colorato, ma i colori degli oggetti non sono né puramente oggettivi, né puramente soggettivi, bensì derivano da interazioni tra le proprietà delle superfici, la luce che le colpisce e ne viene riflessa e le facoltà cognitive umane. Altre specie hanno apparati visivi e neurologici differenti e percepiscono quindi i colori del mondo in modo diverso (Giere, 2006, chap. 2).
Allo stesso modo, anche le rappresentazioni scientifiche sono determinate da una oggettiva presenza di proprietà fisiche (realismo), che interagiscono però in maniera peculiare con le facoltà cognitive umane, con gli strumenti di laboratorio e con i differenti costrutti storici e sociali (prospettivismo).
Quindi la scienza non rivela in maniera oggettiva proprietà intrinseche del mondo, come sosterrebbe il realismo oggettivista, ma non è neanche semplicemente un prodotto dell’osservazione, dipendente dallo strumento e privo di alcun legame con la realtà, come sosterrebbe un approccio puramente sociologico o costruttivista. Gli oggetti scientifici per Giere sono sì proprietà del mondo, ma allo stesso tempo sono determinati anche dall’apparato sperimentale e dal contesto storico e sociale: sono oggettivi ma allo stesso tempo relazionali.
Questa forma di naturalismo metodologico presenta l’indagine scientifica come lo strumento migliore sviluppato dagli esseri umani per comprendere sia il mondo naturale, sia loro stessi come parte di quel mondo e, di conseguenza, un realismo oggettivista è per Giere niente più di una utopia irraggiungibile, mentre è un realismo prospettivista a rappresentare il massimo grado di oggettività a cui la scienza può ambire (Giere, 2006, p. 16).
Bibliografia
Buzzoni, M., 2008. Filosofia della scienza. Ed. La Scuola, Brescia.
Chakravartty, A., 2017. Scientific realism, in: Stanford Encyclopedia of Philosophy. Stanford University, Stanford.
Dicken, P., Lipton, P., 2006. What Can Bas Believe? Musgrave and Van Fraassen on Observability. Analysis 66, 226–233.
Giere, R.N., 2006. Scientific perspectivism, Paperback ed. ed. University of Chicago Press, Chicago, Ill.
Giere, R.N., 1996. Spiegare la scienza: un approccio cognitivista, Saggi. Il Mulino, Bologna.
Ladyman, J., 2002. Understanding philosophy of science. Routledge, London ; New York.
Muller, F.A., Fraassen, B.C. van, 2008. How to Talk about Unobservables. Analysis 68, 197–205.
Musgrave, A., 1985. Realism vs Constructive Empiricism, in: Churchland, P.M., Hooker, C.A. (Eds.), Images of Science: Essays on Realism and Empiricism, Science and Its Conceptual Foundations. University of Chicago Press, Chicago.
Van Fraassen, B., 1985. L’immagine scientifica. Clueb.
[1] Al punto da essere stata inizialmente indicata da Giere col termine quasi ossimorico di ‘realismo costruttivo’ (Giere, 1996, p. 151)