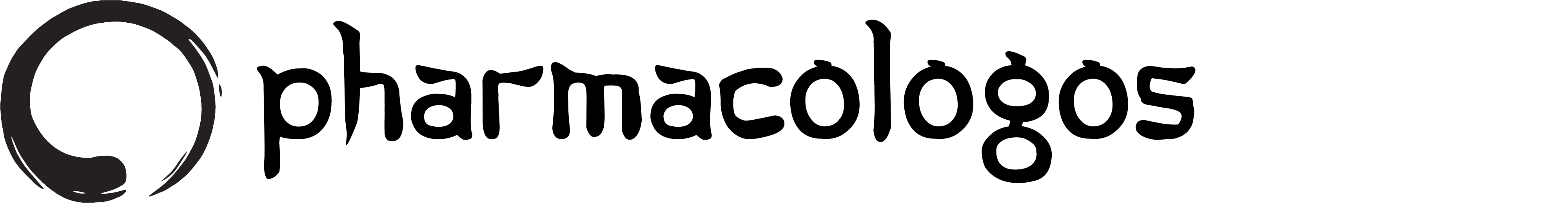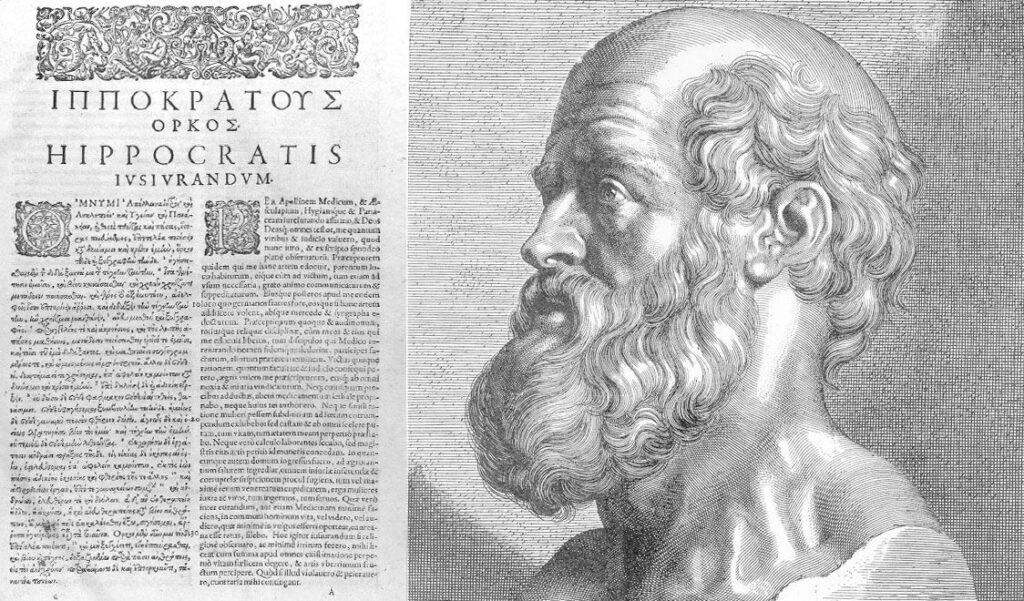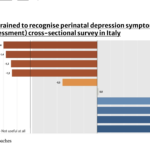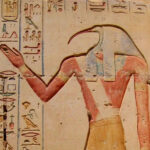Se anche non si possedesse documento né testo alcuno della più antica letteratura medica dei Greci, si dovrebbe pure, fondandoci soltanto sulle espressioni elogiative di Platone sul medico e la sua arte, giungere a concludere che l’età della fine del V e del IV secolo rappresenta nella storia della professione medica uno dei punti di più alto prestigio, sia sotto il rispetto sociale, sia per quello intellettuale.
Jaeger Paideia; Libro IV, Cap I, p 1339 [1]
1. La medicina ippocratica
È ad Ippocrate di Cos che viene in genere attribuito in occidente l’epiteto di “padre della medicina”. Per quanto si sappia veramente poco sulla sua vita, si può ritenere che egli sia nato intorno al 460 a.C. nell’isola di Cos, una delle isole del Dodecaneso in Grecia e sia morto intorno al 370 a.C [1]. Già il fatto che egli sia appartenuto a una famiglia di medici e che abbia studiato medicina sotto la guida di suo padre e di altri maestri, lascia intendere come l’appellativo di ‘padre della medicina’ non sia da interpretare troppo letteralmente. La medicina era infatti già ampiamente diffusa in Grecia prima del V secolo a.C. e la più antica pratica era quella esercitata dai sacerdoti del culto di Asclepio i quali, secondo la leggenda, sostenevano di averla appresa dal centauro Chirone, discepolo diretto del Dio della medicina. Successivamente, accanto ai sacerdoti di Asclepio apparvero anche i cosiddetti ‘medici laici’ i quali non si affidavano più all’intervento divino per le loro terapie, bensì si formavano grazie ad una specifica istruzione, che era organizzata in vere e proprie scuole, comunque quasi sempre associate ai templi di Asclepio [3].[2]
Una delle scuole mediche di stampo laico più accreditate ed innovative del V secolo a.C. fu appunto quella di Ippocrate, il quale è spesso indicato come il primo ad aver trasformato la medicina da una pratica legata alla religione e alla superstizione in una disciplina basata sull’osservazione, l’analisi ed il ragionamento. Ciò che ci resta della sua scuola è il “Corpus Hippocraticum” una raccolta di circa 60 testi, per tradizione attribuiti direttamente ad Ippocrate stesso, ma che derivano in realtà più ragionevolmente dalla compilazione in epoca alessandrina di una summa del materiale in uso nella scuola, e per ognuno dei quali è impossibile risalire ad un autore definito [1].
Ciò che è sicuro è che questi scritti coprono una vasta gamma di argomenti medici, dalla diagnosi alla chirurgia, dall’ostetricia alla nutrizione, introducono il concetto che le malattie sono causate da squilibri naturali piuttosto che da divinità o forze soprannaturali e affrontano anche importanti temi etici, trattati ad esempio nel famoso “Giuramento di Ippocrate”, che sottolinea gli obblighi morali del medico ed i confini della professione. Come è noto, pur con i limiti imposti dal tempo, il “Giuramento” è ancora oggi fortemente rappresentativo dell’etica medica in generale.
Nel V secolo a.C. l’insegnamento della medicina era ancora nettamente esoterico ed avveniva esclusivamente nell’ambito familiare; anche Ippocrate avrebbe trasmesso la propria arte prima ai due figli, per poi allargare il cerchio della famiglia ammettendovi il genero Polibo. Il modello familiare fu successivamente superato ed all’insegnamento furono ammessi membri esterni, a condizione però che stabilissero legami di natura familiare con i propri maestri [5].
L’influenza di Ippocrate nella cultura della sua epoca fu decisamente grande, al punto da essere citato come esempio di medico ‘scientifico’ e come modello del ‘bravo medico’ per antonomasia, sia da Platone (“…ebbene, chi è Ippocrate perché tu gli offra un compenso? […] Io glielo offro perché è medico”; Protagora 311 C; “…esamina che cosa dicono intorno alla natura Ippocrate e il discorso vero”; Fedro 270C-D) [6] sia da Aristotele (“…così si potrebbe chiamare Ippocrate più grande, non come uomo, ma come medico, di uno che lo supera per la grandezza del fisico.”; Politica VII, 4).
2. Medicina e filosofia
Queste riflessioni ci fanno notare come medicina e filosofia siano state strettamente intrecciate fin dall’antichità. Sebbene in epoca contemporanea la pratica medica sia sempre più piegata al tecnicismo e alla ultra-specializzazione, al punto che gran parte dei medici oggigiorno avrebbe difficoltà a individuare i legami tra la propria disciplina e quella di Platone o Aristotele, se allontaniamo lo sguardo dai meri gesti tecnici della diagnosi e della terapia ed assumiamo una visione d’insieme, è fuori di dubbio che la riflessione filosofica giochi ancora un ruolo di enorme importanza nella medicina, intesa come disciplina in sé [3].
Tale ruolo non poteva essere che ancora più rilevante in epoca classica, quando ciò che noi oggi chiamiamo ‘scienza’ non era stato ancora codificato e la cosiddetta ‘filosofia naturale’ aveva una posizione fondamentale nella formazione intellettuale delle professioni sanitarie.
Come ci ha ricordato Werner Jeager in apertura, tutti i protagonisti della filosofia greca del V e IV secolo a.C. (Socrate, Platone e Aristotele in particolare, ma anche i sofisti e i ‘fisici’, tra cui soprattutto i seguaci della scuola di Empedocle, il quale fu medico egli stesso) hanno intrecciato stretti rapporti tra la medicina e le loro posizioni filosofiche, attingendo ampiamente sia al vocabolario che alle teorie mediche nella redazione delle loro opere [1].
2.1 Medicina come τέχνη
La prima posizione che osserveremo è quella della medicina come arte, e partiremo da Platone. Nel “Gorgia” quando intende definire lo statuto della retorica, dimostrando che essa non è una vera ‘arte’ (τέχνη), ma tutt’al più una ‘pratica’ (ἐμπειρία), egli fa l’esempio della medicina come di una τέχνη in senso proprio, fornendoci di fatto un interessante quadro di come fosse da lui considerata questa disciplina:
Perciò io chiamo questa attività [la culinaria, ndr] lusinga e dico che è una brutta cosa, o Polo, e questo lo dico in risposta alla tua domanda.
Infatti, mira al piacere e non al bene. E dico anche che essa non è un’arte ma una pratica, perché non possiede alcuna conoscenza della natura del soggetto cui si rivolge con i suoi consigli, né della natura delle cose che consiglia: perciò non conosce la ragione di ciascuna cosa.
E io non chiamo arte una attività irrazionale.
Platone, Gorgia 464E – 465A [6]
A differenza della culinaria, che vi si è insinuata al di sotto e simula di conoscere i cibi migliori per il corpo, ma in realtà mira solo al piacere (ed è quindi ‘una brutta cosa’), la medicina per Platone è una vera e propria arte (τέχνη) in quanto:
- ha come obiettivo il bene,
- possiede la conoscenza della natura del soggetto a cui si rivolge,
- conosce la ragione con la quale formula i propri consigli.
Spiega ancora Jaeger che secondo Platone “una τέχνη è un sapere intorno a qualche cosa e alla sua natura che sia diretto a giovare agli uomini, e che perciò si attua pienamente, anche in quanto è sapere, solo nell’applicazione pratica. Per Platone il medico è colui che sulla base della sua conoscenza della natura del sano conosce anche il contrario di questo, il malato, e può perciò trovar la via di ricondurlo allo stato normale.” (Paideia, Libro IV, Cap I, p 1372) [1]
Il metodo di questa nuova modalità di esercitare l’arte medica è da Platone ulteriormente descritto nelle Leggi (in questo caso al fine di portare un esempio utile per sviluppare l’arte del legislatore). Qui egli immagina l’incontro tra un medico che si occupa degli schiavi (modello del medico puramente empirista, che esercita niente più che una ‘pratica’) ed un medico degli uomini liberi (modello del ‘medico scientifico’, che basa la sua ‘arte’ sulla conoscenza della natura):
…se un medico di quelli che si basano solo sull’esperienza e prescindono totalmente dalla teoria si imbattesse in un altro medico che, da uomo libero a uomo libero, parlasse al suo paziente, usando termini quasi filosofici per illustrare fin dalle origini il decorso della sua malattia, per elevarsi poi fino alla natura complessiva dei corpi, forse non saprebbe evitare una sonora risata…
Platone, Leggi 857 C – D [6]
In questo passo Platone si schiera ancora una volta a favore della medicina ‘scientifica’, che non si basa esclusivamente sulla empiria, ma possiede fondamenti nella filosofia naturale. Tale disciplina non è però per le masse, ma solo per l’élite della società, e possiede evidentemente una nota di esoterismo, al punto che il medico empirista ‘degli schiavi’ scoppia in una sonora risata osservando il metodo ‘quasi-filosofico’ del collega degli ‘uomini liberi’. Questa medicina scientifica ed esoterica degli uomini liberi è per Platone proprio quella della scuola ippocratica.
In realtà se adottiamo un approccio filologico, spiega ancora Jaeger, la posizione del Filosofo è probabilmente un po’ troppo spostata in direzione della teoria [4]. La scuola ippocratica ha avuto senz’altro il merito di rendere in un certo senso più ‘scientifica’ la medicina dell’epoca che era stata saldamente fondata su principi religiosi, ma ha avuto anche l’importante ruolo di metterne in primo piano gli elementi empirici.
Si tratta però di una ‘empiria attenta’, con la quale Ippocrate “si rifiuta di seguire quei medici che credono essenziale per una vera τέχνη il possesso di un principio unitario al quale tutti i fenomeni singoli si riconducano” (Paideia, Libro IV, Cap I, p 1365) [1].
Scrive infatti l’autore della Antica Medicina (uno dei testi cardine del Corpus Hippocraticum) a proposito di questi medici-filosofi:
…il loro discorso ricade nella filosofia, come appunto quello di Empedocle e di altri, che hanno scritto sulla natura, descrivendo dal principio ciò che è l’uomo e come in origine è apparso e di quali elementi è formato
De veteri medicina, 20 [7]
La posizione dell’autore della Antica Medicina nei confronti delle basi filosofiche della sua arte non è dunque molto tenera, sorprendentemente soprattutto nei confronti dell’illustre ‘collega’ Empedocle. C’è da ricordare infatti che questi fu propugnatore certamente di una medicina iniziatica, esoterica e ancorata alle pratiche religiose, ma rimane pur sempre l’inventore della teoria dei ριζώματα, delle quattro radici, dalla quale sono derivati i quattro elementi (Terra, Aria, Fuoco e Acqua) che hanno profondamente influenzato prima la medicina ippocratica, poi quella galenica ed infine tutta la medicina occidentale per oltre 1500 anni, fino alla rivoluzione scientifica.
Secondo l’autore della Antica Medicina, non bisogna però essere troppo ancorati a “ciò che l’uomo è in principio e agli elementi da cui è formato”, infatti, facendo tesoro della lezione di Anassagora, come scrive Mario Vegetti, “Ippocrate riconosce che nella dimensione dell’empirico non si danno elementi o qualità in sé assolute, bensì oggetti di esperienza sempre variabili e sempre individuabili, che si costituiscono come sintesi concreta della molteplicità inesauribile di elementi e di qualità” [7 p.123].
Non sono l’una dall’altra separate le cose che appartengono ad un unico cosmo, né con l’ascia si può discernere il caldo dal freddo o il freddo dal caldo.
Frammento B8, Anassagora [8]
L’autore della Antica Medicina non rinnega dunque le basi teoriche della propria disciplina, anzi, confermando ciò che ci dice Platone, le tiene in gran conto; tuttavia, egli sposta il punto di vista, focalizzandosi su un altro aspetto della medicina, quello più pragmatico, senza però assolutizzarlo come facevano i medici empiristi, propugnatori di una disciplina esclusivamente pratica.
Gli esempi degli ippocratici sulla alimentazione sono molto utili per spiegare questo punto di vista.
Se si confrontasse il regime (alimentare, ndr) dei malati con quello dei sani, si troverebbe che non è più dannoso di quello dei sani confrontato a quello delle fiere e degli altri animali
De vetere medicina, 8 [7]
L’interpretazione è chiara: una alimentazione normale per un soggetto malato è tanto dannosa quanto l’alimentazione delle bestie selvagge lo è per un soggetto sano. Ma, aggiunge l’autore, non è tutto così semplice: se ciò che è troppo forte nuocesse sempre e ciò che è debole fosse utile sia al malato sia al sano, basterebbe utilizzare i cibi più deboli in tutti i casi per perseguire la salute. Tuttavia, ciò non è possibile, perché in medicina non esiste questa misura oggettiva, assoluta, buona per tutte le occasioni, né per l’alimentazione né per altro.
Conclude infatti esplicitamente il nostro ippocratico:
Ma non troverai misura alcuna, né numero né peso, la quale valga come punto di riferimento per un’esatta conoscenza, se non la sensazione del corpo.
De vetere medicina, 9 [7]
Le risonanze con il pensiero di Aristotele sono qui evidenti e ci consentono di affrontare ora la medicina anche da un punto di vista un po’ diverso rispetto a quello della ben strutturata τέχνη che ci aveva proposto Platone, un punto di vista più vicino a quella ‘saggezza pratica’ che il suo allievo più illustre ha indicato come φρόνησις.
2.2 Medicina come φρόνησις
…in generale, a chi ha la febbre giovano riposo e dieta, ma forse a una certa persona no.
Aristotele, Etica Nicomachea X 9, 1180b [9]
È ben noto che Aristotele ebbe un legame personale con la medicina attraverso suo padre, Nicomaco, il quale sarebbe stato medico di corte del re Aminta III di Macedonia[5]. Questo contesto familiare non solo gli diede accesso alle conoscenze mediche dell’epoca, ma con ogni probabilità influenzò anche il suo approccio empirico e razionale all’indagine filosofica. La sua familiarità con la medicina si riflette nel suo profondo interesse per la biologia, nell’osservazione accurata del mondo naturale e nella sua visione olistica dell’essere umano, nel quale la dimensione fisica e quella mentale/spirituale sono strettamente collegate. Il suo legame con la medicina non solo arricchì il suo pensiero filosofico, ma influenzò profondamente i medici successivi che studiarono e commentarono i suoi scritti di biologia, anatomia e filosofia naturale per oltre mille anni.
Ciò che sappiamo della visione della medicina che ebbe Aristotele, deriva sicuramente in parte dalle numerose opere ‘biologiche’, nella quali tuttavia affronta la questione con l’approccio di un naturalista ante-litteram; queste opere non ci dicono in realtà molto del suo concetto di salute e malattia, del ruolo del medico nella società e del rapporto medico-paziente, quanto piuttosto ci offrono uno spaccato delle conoscenze di base sul mondo naturale.
Molto più interessante in questo senso è invece analizzare gli insegnamenti di stampo etico dello stagirita (non solo le tre Etiche, ma anche le numerose altre opere che contengono spunti morali), nelle quali molto spesso egli presenta similitudini tra l’etica e la medicina. Leggendo cosa pensa della prima, a volte tra le righe, a volte in maniera assolutamente esplicita, capiamo spesso anche cosa pensa della seconda.
Spiega ad esempio Jeager che Aristotele vedeva l’etica come una pratica viva, simile alla medicina; in entrambi i casi, l’obiettivo è raggiungere un bene: la salute per la medicina, una vita virtuosa per l’etica. Come un medico deve conoscere sia la teoria della medicina sia le particolari circostanze del paziente, così anche in etica si devono comprendere sia i principi universali sia le specifiche situazioni umane [11]. Sia l’etica che la medicina richiedono dunque una profonda comprensione della natura umana e la capacità di applicare i principi teorici in modo flessibile in relazione alle circostanze individuali.
Proviamo adesso a schematizzare i riferimenti alla medicina fatti da Aristotele nelle sue opere:
- Medicina come metafora dell’etica: Aristotele utilizza spesso la medicina come metafora per illustrare i principi etici o politici. Ad esempio, assimila l’arte del medico nell’identificare e curare le malattie alla capacità del filosofo di comprendere e applicare i principi etici o a quella del legislatore nel formulare leggi giuste e interpretarle a seconda dei casi.
- Salute come bene: la salute è spesso citata come un bene desiderabile, e la medicina è l’arte che permette di raggiungere questo bene. In questo riecheggiano sia la teleologia tipica dello Stagirita, sia la necessità per l’uomo di perseguire sempre un ‘bene pratico’. La salute è spesso presentata come un fine intermedio, da perseguire per raggiungere un fine ulteriore (la felicità).
- Malattia ed equilibrio: la malattia è menzionata spesso in relazione all’equilibrio e alla giusta misura, concetti chiave nella filosofia aristotelica. La malattia può essere vista come una deviazione dall’equilibrio, e la medicina come l’arte di ripristinare l’armonia.
Ma soprattutto, ai fini che qui ci poniamo, sono importanti i seguenti aspetti:
- Medico come esperto: Il medico è molto spesso presentato come un soggetto esperto che non solo identifica e cura le malattie, ma che agisce anche con saggezza esercitando una conoscenza pratica che trascende sia la pura teoria, sia la mera tecnica.
- Medicina come arte pratica: la medicina è di conseguenza fondamentalmente presentata come un’arte pratica (φρόνησις) che ha il fine specifico della salute.
2.2.1 Una scienza fragile
Dal punto di vista di Aristotele quindi, la medicina è sì un’arte (τέχνη), ma non in senso stretto come la presentava Platone, senza tuttavia essere considerata una partica puramente empirica (ἐμπειρία) che si occupa dei casi singoli senza fare riferimento a una cornice teorica universale.
Inoltre, seguendo in questo Platone, Aristotele non trascura la terza dimensione alla medicina, quella della ἐπιστήμη, cioè una scienza del vero, una disciplina basata su una conoscenza certa e universale. Più precisamente, se da un lato Aristotele riconosce una dimensione epistemica all’interno della medicina (quella che si riferisce al corpus teorico delle conoscenze mediche e abbraccia l’universale), egli contemporaneamente sottolinea come la declinazione pratica di tale disciplina ricada inevitabilmente nel dominio del particolare [12]. Né Aristotele, né Ippocrate (ma con ogni probabilità neanche Platone) pensavano infatti che la medicina umana potesse raggiungere il livello di certezza di una ἐπιστήμη in senso stretto (come ad esempio la matematica); infatti, essendo una disciplina necessariamente calata nel particolare, come per tutte le altre ‘scienze umane’, “ci si deve accontentare […] che la verità venga mostrata approssimativamente e a grandi linee”, dal momento che “non si deve cercare la stessa precisione in tutti i discorsi”, ma “fare luce per quanto lo permette la materia trattata” (Etica Nicomachea I 3, 1094b [9]). Sottolinea Martha Nussbaum che il riferimento qui è alle nozioni tecniche di τέχνη ed ἐπιστήμη “come sistema deduttivo completamente dedicato agli universali […] nel senso richiesto dalla Repubblica o dagli Analitici Secondi” [13 p.539].
Se lo Stagirita in diversi passi fa riferimento alla medicina come ἰατρικὴ ἐπιστήμη (come ad esempio in Etica Eudemia II, 10, 1227a [9] o in Topici VI, 3, 141a [14]), in un passo molto chiaro della Grande Etica mette queste affermazioni in prospettiva: “esattamente come nell’ambito della medicina tutti sanno in generale ciò che è salutare e ciò che in grado di produrre la salute, come ad esempio sappiamo che l’elleboro, la purga, le operazioni e le cauterizzazioni sono salutari e sono in grado di produrre la salute, ma non per questo possediamo la scienza medica; infatti non sappiamo ciò che è bene in ogni singolo caso, come il medico sa per chi questo <rimedio> è buono, quando e in quale disposizione; è in questo, infatti, che risiede la scienza medica. Dunque, pur sapendo ciò che è salutare in generale, non per questo siamo detentori della scienza medica” (Grande Etica II, 3, 1199 a [9]).
Quindi per Aristotele la medicina è da un certo punto di vista una ἐπιστήμη, mentre da un altro è una τέχνη e, allo stesso tempo, è una τέχνη in un senso (quello di arte pratica guidata da principi generali, ma inevitabilmente calata nel particolare), ma non lo è in un altro ancora (quello tipico invece di Platone, di arte tecnica, quasi-scientifica, basata sulla fedele applicazione di principi generali ai casi particolari).
Si tratta quindi di una disciplina che unifica entrambi gli approcci: il medico fa riferimento a una scienza per muoversi con le coordinate dell’universale, ma deve individuare di volta in volta ciò che è giusto a seconda delle circostanze dei casi particolari, facendo ampiamente ricorso alla virtù della saggezza (φρόνησις). Come suggerisce Jaeger, Aristotele, trattando dell’etica, prende l’arma dell’esempio medico dall’arsenale di Platone stesso, ma la rivolge contro la conclusione del suo maestro: egli dimostra infatti la necessità di un diverso tipo di conoscenza che sia in grado di individuare quale sia il ‘bene pratico’ nel singolo caso piuttosto che trascendere le differenze presenti nell’esperienza pratica, con l’illusione di perseguire il ‘sommo bene’ [11].
Si potrebbe dire che da questo punto di vista la medicina è sì una scienza, ma è una scienza fragile: pone le sue fondamenta su principi universali, ma si erge sulla instabile faglia del particolare, che ad ogni occasione ne minaccia la stabilità.
2.2.2 In continuo movimento tra il particolare e il generale
Di conseguenza, per Aristotele, il punto di riferimento per l’agire medico non è tanto rappresentato dalla conoscenza e dalla applicazione pedissequa dei principi universali della medicina al caso singolo (come sembra suggerire Platone), quanto piuttosto dal riferimento al comportamento di un medico ideale, eccellente (impersonato in questo senso da Ippocrate), il quale viene ad assumere in medicina il ruolo che in etica hanno il φρόνιμος, lo σπουδαῖος, il καλός κἀγαθός, che rappresentano tre punti di vista sull’uomo perfettamente saggio, colui che possiede tutte le virtù e che le esercita, ed il cui comportamento può sempre essere preso a modello per una vita buona [15 p.296-299].
Si deve sì guardare sempre ai principi, dunque, ma calati nella pratica, come farebbe un uomo (e un medico) massimamente saggio e virtuoso. Scrive infatti Aristotele in chiusura dell’Etica Eudemia: “in un senso, infatti, è principio la medicina e in un altro la salute; e quella è in vista di questa” (Etica Eudemia VIII 3, 1249b [9]); portando avanti la similitudine, in medicina come in etica ci deve per forza essere un qualche criterio, sia per possedere, sia per scegliere, e questo criterio consiste nel fatto di guardare al principio [15 p.300].
Questa importanza dell’equilibrio tra dimensione teoretica e dimensione empirica dell’etica, e quindi della medicina, è ben presentata in Etica Nicomachea X 9:
…sembrerebbe che debba passare attraverso l’universale chi vuole diventare un esperto dal punto di vista tecnico e chi vuole acquisire una capacità teoretica, e che debba conoscere l’universale per quanto è possibile
Aristotele, Etica Nicomachea X 9, 1180b [9]
Se quindi da una parte Aristotele sembra condividere il punto di vista di Platone sull’importanza di un quadro teorico di riferimento (ma sempre per quanto è possibile), da un altro lato egli chiarisce inequivocabilmente l’importanza fondamentale della dimensione empirica:
Ma forse nulla impedisce che di un qualche individuo in particolare si prenda cura adeguatamente anche chi non possiede la scienza ma ha osservato con attenzione che cosa avviene nei singoli casi per mezzo dell’esperienza, proprio come alcuni sono stimati essere i migliori medici di se stessi, mentre non sarebbero capaci di portare soccorso ad altri.
Aristotele, Etica Nicomachea X 9, 1180b [9]
D’altra parte, chiarisce inequivocabilmente Aristotele in Etica Eudemia I, 1217b: “vogliamo stare in salute, piuttosto che sapere che cosa significhi stare in salute” [9,12]. E la filologia attuale sembra in effetti essere indirizzata su una descrizione della medicina ippocratica più simile a come ce la presenta Aristotele, che non a quella di Platone. L’analisi contemporanea, infatti, non si concentra più tanto sull’immagine di un’arte ben definita e su un modello simbolico prestabilito, bensì rivela diverse figure di varia natura e a volte in conflitto tra loro: praticanti di esorcismi, ‘recisori di radici’, ‘commercianti di farmaci’, sacerdoti, ostetriche, medici pubblici o privati, e così via. La dottrina ippocratica non è oggi più vista come una disciplina unificata, che parte da principi teorici condivisi, quanto piuttosto come dotata di una natura intrinsecamente varia e sfaccettata [5]. Ed il legame con la pratica era sicuramente molto più forte che quello con la teoria.
Ciò che rientra nell’ambito della prassi e dell’utile non ha nulla di stabile, e lo stesso vale per ciò che rientra nell’ambito della salute. E se il discorso in generale ha queste caratteristiche, a maggior ragione mancherà di precisione il discorso sui casi singoli; infatti, non rientra in nessuna tecnica né in alcuna serie di precetti, ma è pur sempre necessario che chi agisce guardi alla situazione che si trova di fronte, proprio come nel caso della medicina e del pilota della nave.
Aristotele, Etica Nicomachea II 2, 1104a [9]
La deliberazione medica, come quella pratica tipica dell’etica non è quindi scientifica, e non può esserlo (“che poi la saggezza non sia una scienza è chiaro” Etica Nicomachea VI 8, 1142a [9]). Spiega Martha Nussbaum che quando ci dedichiamo a questa “deliberazione non scientifica” nella vita di tutti i giorni, veniamo confusi dalla particolarità dei casi che continuamente si presentano alla nostra decisione. Ciò comporta che ci viene a mancare una comprensione scientifica della sfera pratica, non riusciamo a organizzarla, spiegarla e assumere verso di essa lo “sguardo del Dio” che suggeriva Platone. Un’altra conseguenza è che le nostre azioni sono “vulnerabili alla fortuna” (τύχη), non possiamo cioè avere una soluzione precostituita per ogni situazione (un manuale di istruzioni, diremmo noi oggi), quanto piuttosto delle “linee guida”, delle regole empiriche che al massimo ci possono aiutare ad applicare ai casi particolari i principi universali, prendendo come modello di comportamento, in etica, l’uomo perfettamente saggio e, in medicina, il nostro Ippocrate, il medico ideale [13 p. 550-552]. Scrive ancora Martha Nussbaum che questa deliberazione non scientifica è “un movimento flessibile avanti e indietro tra il particolare e il generale” e che “la nuova esperienza può anche portare ad uno sviluppo o a una trasformazione della concezione generale” [13 p 576].
In definitiva, al centro della pratica medica c’è per Aristotele lo stesso principio che egli pone alla base di tutte le questioni relative alla ricerca di una ‘vita buona’: fare la cosa giusta, alla persona giusta, nel modo giusto, per il motivo giusto e nel momento giusto.
Ed è per questo che in medicina assume particolare importanza uno degli aspetti fondamentali della φρόνησις: la capacità di cogliere il ‘momento opportuno’, il καιρός.
2.2.3 Il καιρός in medicina
…del momento opportuno (καιρός) si occupa in caso di guerra l’arte militare e in caso di malattia la medicina, e della giusta misura (μετρίον) si occupano, rispetto alla alimentazione la medicina, rispetto agli esercizi la ginnastica.
Aristotele, Etica Nicomachea I 6, 1096a [9]
La vita è breve, l’arte vasta, l’occasione (καιρός) fuggevole, l’esperienza fallace, il giudizio arduo.
Aforismi, 1 Corpus Hippocraticum [7]
Sia Aristotele, sia i medici ippocratici sono d’accordo che per curare bene una persona è necessario di volta in volta individuare il καιρός, “l’occasione fuggevole”. Questo concetto viene comunemente interpretato come “il tempo giusto”, anche se in questo caso l’accezione non è solo temporale, ma si riferisce a tutte le circostanze che vanno colte in ogni singolo caso perché un intervento medico sia efficace.
Il καιρός come momento giusto
Come molto spesso avviene in Aristotele, il καιρός in medicina è un concetto multifocale e può essere affrontato da diversi punti di vista. Una concezione del καιρός che potremmo chiamare ‘biologica’, fa riferimento ai ritmi naturali e ai cicli che governano gli organismi viventi ed è tipica delle opere naturalistiche dello Stagirita, nelle quali appare molto frequentemente: De generatione animalium 14 volte, Historiae animalium 26 volte, De partibus animalium 4 volte, Metereologica 3 volte [16].
È noto che per Aristotele, la natura opera seguendo un ordine intrinseco ed un ritmo prestabilito; molti fenomeni biologici hanno una loro precisa temporalità che deve essere rispettata, ad esempio ci sono specifici tempi di guarigione necessari dopo una lesione ed esistono precise fasi di crescita necessarie attraverso le quali un organismo si sviluppa. Il καιρός, in questo contesto, rappresenta quel “tempo giusto” in cui questi fenomeni biologici sono destinati a verificarsi, se non si verificassero in queste tempistiche sarebbe un problema. Questa accezione del καιρός fa evidentemente riferimento al concetto di medicina come ἐπιστήμη, come scienza stabile: il tempo della natura è inscritto nella natura stessa ed il medico lo può conoscere con lo studio scientifico della φύσις. Sotto questo punto di vista il καιρός di ogni circostanza sarà sempre quello, perché il suo tempo è il tempo della natura ed il medico può conoscerlo in maniera stabile e relativamente certa.
Questo modo in un certo senso ‘oggettivo’ di intendere questo concetto, risuona con il pensiero degli autori che hanno cercato di superare la distinzione classica che vedeva il κρόνος come concetto temporale quantitativo ed ontologico, caratterizzato dall’uso dei numeri cardinali, ed il καιρός per contrasto come tempo qualitativo ed esperienziale, dipendente dalla soggettività del singolo e caratterizzato dall’uso dei numeri ordinali [17]. È stato invece ampiamente osservato che non dovremmo concentrarci troppo sulla natura interpretativa, retorica e ‘antropologica’ del καιρός, in quanto esso dipende da cornici temporali che sono indipendenti dall’azione umana.
Scriveva Platone [Leggi, 709b]: “Il caso (τύχη) e l’opportunità (καιρός) cooperano con il Divino nel controllo di tutte le umane vicende” [6]. Sebbene il καιρός sembri riferirsi solo all’azione individuale e al giudizio soggettivo, tale giudizio ‘non crea il quando da solo’: le opportunità vanno e vengono, che qualcuno le veda o meno, che qualcuno le colga o meno [18].
Conseguentemente, si può affermare che il καιρός possiede una sua dimensione ontologica, fisica e metafisica, la quale è perfettamente descritta dall’uso del concetto che ne fa Aristotele nelle sue opere biologiche.
Anche in medicina il καιρός può però essere affrontato dal punto di vista più classico, o ‘soggettivo’, cioè quello che indica il momento opportuno per l’intervento medico, con una concezione che potremmo chiamare ‘clinica’. In caso di malattia o disturbo, esiste cioè sempre un “momento giusto” per intervenire, un momento in cui il trattamento è massimamente efficace o in cui un intervento potrebbe prevenire ulteriori complicazioni. Recita uno degli aforismi ippocratici: “La guarigione è una questione di tempo (κρόνος), ma è anche una questione di opportunità (καιρός)” [7]. Questa accezione del καιρός sottolinea la necessità per i medici di possedere non solo specifiche conoscenze dell’universale (secondo la ἰατρικὴ ἐπιστήμη), ma anche una profonda intuizione e sensibilità (la saggezza conferita dalla φρόνησις) per riconoscere quel momento cruciale in cui agire nel particolare di ogni singola circostanza, per ogni singolo individuo. Questa visione risente anche degli insegnamenti di Pitagora: scrive infatti Giamblico (suo biografo) che il καιρός è qualcosa che appartiene all’intuito personale, infatti è legato ‘alla tempestività, al conveniente, all’appropriato’, cioè alla multiforme varietà delle situazioni [19]. Anche le emozioni devono sottostare a questa legge: ‘c’è chi è preso dalla rabbia e dalla furia in modo giusto (εὐκαίρως) e chi invece in modo inadeguato (ἀκαίρως)’, e gli stessi appetiti e desideri in alcuni casi sono appropriati, in altri inappropriati [19].
Non c’è dubbio che questa accezione di καιρός evidenzi ancora una volta la fragilità della scienza medica perché, come dicevano gli ippocratici, “l’occasione è fuggevole” e per quanto salda sia la ἐπιστήμη, senza la φρόνησις è impossibile sostenerla.
Il καιρός come giusto mezzo
Infine, il καιρός va evidentemente di pari passo con il concetto di μεσότης, il giusto mezzo, cardine dell’etica aristotelica, che però possiede anche un importantissimo ruolo in medicina. Come nell’etica, anche in terapia il trattamento efficace (≡ virtù) si trova alla giusta distanza (NB non alla metà aritmetica della distanza, bensì ad una distanza variabile da caso a caso) tra due trattamenti inefficaci o tossici (≡ vizi). Se pensiamo a un trattamento farmacologico, questo concetto appare chiaro: in ogni terapia esiste una dose corretta (che non è la dose corretta per tutti, è la dose corretta per quel singolo paziente); in genere, se utilizziamo una dose più bassa, il trattamento non sarà efficace, se invece utilizziamo una dose troppo alta, il trattamento potrà rivelarsi tossico (non dimentichiamo che non a caso in greco φάρμακον significa sia ‘rimedio’ che ‘veleno’).
Lo stesso, poi, accade nel caso delle bevande e dei cibi: se sono molti rovinano la salute, come pure se sono pochi, mentre se sono in giusta misura salvaguardano la salute e la forza.
Grande Etica I, 5, 1185b [9]
La virtù del medico sta ancora una volta nel cogliere il καιρός, in questo caso non solo in senso temporale, ma anche in riferimento alla μεσότης, al mezzo che è giusto per quel singolo paziente, con quella specifica condizione clinica, in quello specifico caso che stiamo valutando[6].
«È evidente, infatti, che il medico non prende in esame la salute in assoluto, ma quella dell’essere umano, e anzi, ancora di più, quella di quest’essere umano qui; infatti, egli cura i singoli individui».
Aristotele, Etica Nicomachea I 6, 1097a [9]
È però opportuno sottolineare come il concetto di καιρός in medicina nel pensiero greco non viva isolato, ma sia strettamente interconnesso con altre idee fondamentali. Ogni καιρός implica una κρίσις, un momento di decisiva importanza in cui l’azione che si compie ha come esito il successo o il fallimento [20]. Dicono infatti gli ippocratici che il medico non dovrebbe essere abile solo nella descrizione, ma anche nell’interpretazione dei segni e dei segni della malattia. Una volta che tutti i fatti sono stati raccolti, il medico deve fare una raccomandazione basata su una combinazione di sintomi, esperienza e istinto. È qui che il καιρός diventa ancora più complesso: l’enorme numero di fattori coinvolti nella malattia umana e nella guarigione può essere disarmante; il medico dovrà essere esperto in molte più cose rispetto alla sola medicina [16]. Per risolvere questa κρίσις, è ancora Aristotele che ci viene in aiuto grazie alla trattazione di grandissima importanza della distinzione tra potenza e atto che egli fa in Metafisica Θ e che può facilmente essere applicata alla medicina: mentre il καιρός ci parla soprattutto del “quando”, la distinzione tra potenza e atto ci da maggiori informazioni sul “come” e sul “perché”.
2.2.4 Potenza ed atto in medicina
…mentre tutte le potenze razionali sono le stesse per ambedue i contrari, quelle irrazionali sono invece, ciascuna, potenza di un solo contrario: il caldo, per esempio, è potenza solo di riscaldare, mentre l’arte medica è potenza della malattia e della salute. Aristotele, Metafisica Θ IΙ, 1046b [21]
Le due colonne su cui si basa ogni pratica medica, sono la diagnosi e la terapia. La diagnosi avviene nel momento cruciale in cui il medico e il paziente si incontrano. L’abilità e l’esperienza del medico si uniscono ai sintomi e alle preoccupazioni del paziente, descrivendo insieme una mappa che diviene la base per identificare il problema e progettare il miglior piano di cura. La terapia è naturalmente il passo successivo, e consiste nell’applicazione pratica del sapere e delle intuizioni del medico, per controllare o trattare la condizione identificata. È un secondo momento cruciale in cui il medico interviene, mettendo in pratica una serie di procedure e di tecniche volti a migliorare la salute del paziente. Questi due processi possono essere analizzati e compresi attraverso i concetti aristotelici di potenza (δύναμις) e atto (ἐνέργεια).
Aristotele descrive la potenza più o meno come “il principio del movimento o del cambiamento”, ne dà diversi esempi, anche se non ne fornisce una vera e propria definizione (“infatti, non bisogna cercare definizione di tutto, ma bisogna accontentarsi di comprendere intuitivamente certe cose mediante l’analogia” Metafisica Θ 1, 1048a). In sintesi, la δύναμις rappresenta un potenziale o una capacità non ancora realizzata. Si tratta di una condizione preliminare o di uno stato di possibilità che, una volta attivato o voluto, può passare all’essere in atto, cioè alla realizzazione effettiva. Questo passaggio dall’essere in potenza all’essere in atto è evidente in vari ambiti, come nelle arti e nelle tecniche, in cui la potenza rappresenta la capacità intrinseca di realizzare qualcosa, ma richiede sempre condizioni favorevoli esterne e interne per manifestarsi pienamente, nonché naturalmente una causa efficiente che lo realizzi.
L’arte medica in particolare, come ci suggerisce la citazione in apertura del paragrafo, è ‘potenza razionale’, una definizione con cui Aristotele si riferisce alla capacità intrinseca di un agente razionale di agire in conformità con il suo potenziale ed il suo desiderio (ma pur sempre limitato da determinate condizioni esterne). Questa potenza razionale si manifesta attraverso l’azione dell’agente razionale, il quale, nell’ambito delle varie potenzialità, agisce come causa efficiente e realizza ciò che desidera e sceglie.
Ciò di cui si dice che può essere sano, è quel medesimo soggetto che può anche essere malato, ed esso ha potenza di essere sano e malato nello stesso tempo. Infatti, la potenza di esser sano e di esser ammalato è la medesima. Aristotele, Metafisica Θ 9, 1051a [21]
Spiega Reale che “le arti e le tecniche, che dipendono dal pensiero, passano dall’essere in potenza all’essere in atto quando sono volute e nulla si opponga dal di fuori come impedimento, e neppure dall’interno dell’oggetto stesso cui esse si applicano. Per esempio, l’arte medica passa dalla potenza all’atto, ossia trae il malato dalla potenza all’atto della salute, quando il medico abbia deciso di applicare la sua attività e non vi siano impedimenti esteriori (di tempo, di luogo e simili), e il malato non presenti impedimenti interiori, ossia tutte le membra del corpo del malato siano in grado di ricevere la salute.” [15 p.150]
Nelle parole di Aristotele:
Per quanto concerne le cose che dipendono dalla ragione, la questione può così definirsi: esse passano dall’essere in potenza all’essere in atto, quando siano volute e non intervengano ostacoli dal di fuori; nel caso, poi, di colui che deve essere guarito, quando non ci siano impedimenti interni.
Aristotele, Metafisica Θ 7, 1049a [21]
In medicina, quindi, la potenza può essere vista come la capacità potenziale e inerente che esiste nella possibilità di identificare una malattia (diagnosi) e di portare alla guarigione o al miglioramento di una condizione medica (terapia), ma pur sempre nel caso che sia rispettato il καιρός, e non vi siano “ostacoli dal di fuori o impedimenti interni”.
Nel contesto della diagnosi, questo significa che il medico, grazie alle sue competenze, conoscenze e intuizioni, possiede la potenza di discernere e identificare la malattia. In particolare, la potenza nella diagnosi medica si riferisce alla possibilità che il paziente manifesti una serie di sintomi che potrebbero corrispondere a diverse malattie. Questa potenza è inerente ma latente, in attesa di essere realizzata attraverso l’atto della diagnosi. Il medico si trova quindi di fronte a una moltitudine di possibilità diagnostiche, ciascuna delle quali rappresenta una potenza “contraria” alle altre, che potrebbe essere o non essere realizzata.
Se da un certo punto di vista questo potenziale diagnostico è intrinseco al paziente, la cui patologia potrebbe corrispondere o non corrispondere una delle molteplici diagnosi possibili, da un altro punto di vista esso è intrinseco anche al medico, è cioè determinato dalla sua formazione e dalla sua esperienza, ma rimane in uno stato latente o potenziale fino a quando non si realizza in un caso specifico.
L’atto, in questo contesto, si manifesta quando il medico applica questa potenza diagnostica ‘attiva’ a quella ‘passiva’ del paziente, ed identifica una specifica malattia o condizione in uno specifico caso.
Ciò che è in potenza, è in potenza qualcosa di determinato, in un tempo determinato e in una maniera determinata […] alcuni esseri sono capaci di muovere secondo ragione e le loro potenze sono razionali […] tutte le potenze irrazionali, singolarmente prese, possono produrre uno solo dei contrari, mentre le altre possono produrre ambedue i contrari […] In questo caso è necessario che ci sia qualcos’altro che decida: questo è il desiderio, ovvero la scelta razionale.Aristotele, Metafisica Θ 7, 1049a [21]
Nella terapia, la potenza si manifesta invece nella definizione e nella scelta del trattamento appropriato, guidato dall’esperienza e dalla comprensione del medico, e si tramuta in atto prima nel momento della sua applicazione e, in ultima analisi, nel momento della guarigione del paziente. Aristotele sottolinea infatti che l’atto è la realizzazione effettiva, piena e perfetta, di ciò che è in potenza; anche la capacità di guarire è già in potenza nel paziente, ma si tramuta in atto nel momento in cui la potenza terapeutica del rimedio utilizzato diviene a sua volta atto terapeutico.
Quando un medico sceglie un trattamento specifico, ad esempio una terapia farmacologica, la sua efficacia è inizialmente solo in potenza, cioè nella capacità del trattamento di curare la malattia, che non è ancora stata realizzata ma che risiede come potenziale nel trattamento stesso. L’atto si verifica invece quando il trattamento scelto produce il risultato desiderato, cioè la guarigione del paziente.
Non tutto può essere guarito dall’arte medica oppure dal caso, ma può essere guarito solo ciò che è in grado di essere guarito, e, questo, è ciò che ha la salute in potenza.
Aristotele, Metafisica Θ 7, 1049a [21]
In medicina, come in ogni altro caso, il passaggio dalla potenza all’atto non è quindi un processo automatico. Richiede innanzitutto che il paziente abbia “la salute in potenza” e poi l’intervento di una causa efficiente, un agente esterno, il medico in questo caso, il quale mediante l’osservazione, l’esperienza e la comprensione guida il trattamento dalla potenza all’atto.
L’atto della terapia non è quindi solo il risultato finale nel momento della guarigione, ma è anche un processo continuo di trattamento, una attività (ancora ἐνέργεια) che non è compiuta in sé, ma è in continuo dinamismo. In questo senso la salute non è un τέλος esterno da raggiungere, ma è quasi come fosse un τέλος interno all’atto stesso del curare. Ogni trattamento non è statico e chiuso in sé stesso, ma è un processo dinamico che si sviluppa continuamente dalla potenza all’atto. Ogni fase della terapia contiene elementi sia della potenza sia dell’atto, e il suo successo dipende dalla capacità del medico di navigare tra questi elementi, cogliendo ogni volta il necessario καιρός.
La terapia medica non è perciò né un evento pratico isolato, né la mera applicazione di principi universali a condizioni particolari, bensì un processo continuo e dinamico che si sviluppa e si adatta di volta in volta, nel tempo e nel modo opportuno, alle necessità del paziente. La capacità del medico di muoversi fluidamente tra potenza e atto, e di cogliere ogni volta il corretto καιρός è fondamentale per il successo della terapia, ma, ancora una volta, è fonte di fragilità.
La Priorità dell’Atto
Per possedere le potenze che si acquistano con esercizio e istruzione, è necessaria una precedente attività
Aristotele, Metafisica Θ 5, 1047b [21]
È evidente che per realizzare in atto ogni potenza sia della diagnosi sia della terapia, il medico deve fare affidamento sulla sua esperienza e sulle sue conoscenze pregresse, ovvero su atti già realizzati. Solo attraverso la precedente esperienza diretta o l’apprendimento da altri medici delle informazioni sulle malattie che osserva, il medico può acquisire la capacità di riconoscere i sintomi e correlarli a una diagnosi o una terapia specifica per il caso in oggetto. Ci dice Aristotele che “per possedere le potenze che si acquistano con esercizio e istruzione, è necessaria una precedente attività” (Metafisica Θ IΙ, 1047b [21]). Nel contesto della diagnosi ciò significa che il medico deve avere un riferimento precedente relativo ai segni e ai sintomi in atto nel paziente, in modo da poter scegliere tra le possibili diagnosi in potenza; nel contesto della terapia medica, invece il medico deve aver osservato (o appreso da altri) casi in cui la malattia è stata trattata con successo con uno specifico trattamento.
Detto in termini più vicini ad Aristotele, questa osservazione e conoscenza degli atti pregressi permettono al medico di identificare le diagnosi ed i trattamenti in potenza. La conoscenza degli atti passati fornisce la base per identificare le potenze future, guidando il medico nella selezione e nella applicazione di diagnosi corrette e terapie efficaci.
Questa condizione, piuttosto intuitiva per chiunque abbia mai avuto a che fare con questioni mediche, risuona in ambito filosofico con ciò che Aristotele nel capitolo 8 di Metafisica Θ chiama “la priorità dell’atto”, la quale viene presentata ed analizzata in tre modi: ontologico (“secondo la sostanza”), causale (“secondo il tempo”) ed epistemologico (“secondo la nozione”).
- Priorità ontologica
- Secondo Aristotele, l’atto è “più vero” e ha una realtà maggiore rispetto alla potenza, poiché esiste in sé e per sé, mentre la potenza esiste solo in relazione a un atto possibile. L’atto è concreto e determinato, mentre la potenza rimane indeterminata finché non è attribuita a un soggetto specifico. L’atto è completo, perfetto e realizzato, mentre la potenza è in un certo senso imperfetta e in attesa di realizzazione. Nella pratica medica, la realtà di una malattia precedentemente diagnosticata è concreta e determinata, mentre una diagnosi potenziale è indeterminata e insussistente fino alla sua determinazione.
- Priorità causale
- L’atto è anche la ragione stessa dell’esistenza della potenza, poiché la potenza ha bisogno di un atto per diventare realizzata [7]. In altre parole, l’atto è ciò che rende possibile la potenza, trasformando il potenziale in realtà. L’atto può essere visto come la causa efficiente della potenza: ciò che mette in movimento la potenza e la guida verso la realizzazione [22]. Nel contesto medico, l’esperienza e l’apprendimento delle diagnosi o terapie precedenti (atto) servono come cause efficienti che abilitano e giustificano il medico a diagnosticare o trattare nuovi casi (potenza).
- Priorità epistemologica
- Infine, l’atto ha una priorità sulla potenza anche “secondo la nozione”, ovvero, è più conosciuto della potenza, poiché è attraverso l’esperienza degli atti passati che si possono conoscere le potenzialità future. In altre parole, la conoscenza dell’atto è primaria e fondamentale, mentre la conoscenza della potenza è derivata e secondaria. Nel contesto medico, è evidente come l’esperienza diretta e l’apprendimento delle diagnosi o terapie passate (e quindi in atto) forniscano la base epistemologica per comprendere e identificare le potenzialità diagnostiche o terapeutiche future.
3. Conclusioni
In conclusione, da questo excursus nel pensiero greco antico, la medicina emerge come un’arte, una pratica ed una scienza profondamente fragile. Le sue radici affondano in principi universali e in teorie strutturate che cercano di dare ordine e comprensione al vasto dominio della salute umana. Tuttavia, al di là di questi principi, la medicina si confronta continuamente con la complessità e l’unicità del particolare: ogni individuo, ogni malattia, ogni sintomo porta con sé sfide e variabili che non possono essere sempre pienamente catturate da teorie universali.
Articolata tra arte, scienza e disciplina empirica, la medicina si svela come un campo in cui la conoscenza teorica e l’applicazione pratica si intrecciano in un equilibrio dinamico. L’identificazione del ‘momento opportuno’ emerge come principio fondamentale, e rimarca l’importanza del giudizio clinico nel cogliere il tempo giusto e le giuste circostanze per gli interventi terapeutici. Questa percezione del tempo e dell’opportunità evidenzia la delicatezza dell’atto medico, che si colloca costantemente tra la certezza della scienza e l’incertezza dell’individuale.
La nozione di ‘giusta misura’ enfatizza ulteriormente come la medicina operi in un continuo tentativo di bilanciare eccessi e carenze. Questo equilibrio, necessario sia nella diagnosi sia nel trattamento, riflette la sfida di adattare principi universali alla singolarità del paziente, sottolineando la necessità di navigare tra polarità per promuovere il benessere.
Infine, anche la transizione dalla potenza all’atto illustra la complessità della pratica medica: la trasformazione del potenziale di guarigione in un risultato tangibile richiede una fusione di conoscenza, intuizione ed esperienza. Il successo terapeutico non risiede solo nelle basi teoriche ma soprattutto nella capacità di rispondere con efficacia alle imprevedibili variabili dell’esperienza.
Una esplorazione di questo genere non vuole tanto mettere in luce la fragilità della medicina come scienza, quanto piuttosto arricchire il nostro apprezzamento per la pratica medica come un’arte che necessita di saggezza, di sensibilità al momento opportuno, nonché di una profonda comprensione del delicato equilibrio tra teoria e pratica, universalità e particolarità.
Questa perenne tensione tra l’universale ed il particolare rende la medicina una disciplina in continua evoluzione, sempre alla ricerca di un equilibrio tra ciò che è stabilito e ciò che è mutevole, tra ciò che è conosciuto e ciò che rimane da conoscere.
È per questo che l’abbiamo definita una scienza fragile: allora come oggi, la medicina, per quanto possa basarsi su solide fondamenta teoriche, è perpetuamente sfidata dalla diversità e dalla complessità dell’esperienza empirica; apparentemente è salda, ma in realtà è a rischio di crollare ogni qual volta debba scontrarsi con l’imprevedibile varietà delle condizioni umane.
Questa fragilità non è però da intendersi come una debolezza ma piuttosto come un promemoria della sua essenza profondamente umana, che richiede umiltà, precisione e un impegno costante verso l’eccellenza e il miglioramento.
4. Bibliografia
1 Jaeger W. Paideia: la formazione dell’uomo greco. Milano: Bompiani 2013 1933.
2 King H. Hippocrates now: the ‘father of medicine’ in the internet age. London ; New York, NY: Bloomsbury Academic 2019.
3 Reale G, Antiseri D. Il pensiero occidentale. 1. Antichità e Medioevo. 2013.
4 Reale G. Storia della filosofia greca e romana. Bompiani 2018.
5 Debru A. Scienza greco-romana. Pensiero medico e pratica della medicina nei trattati ippocratici in ‘Storia della Scienza’. Enciclopedia Treccani. Treccani 2001. https://www.treccani.it/enciclopedia/scienza-greco-romana-pensiero-medico-e-pratica-della-medicina-nei-trattati-ippocratici_(Storia-della-Scienza) (accessed 15 August 2023)
6 Platone. Tutti gli scritti. 7a ed. Milano: Bompiani 2014.
7 Hippocrates. Opere. 1st ed. UTET 1965.
8 Diels H, Kranz W. I Presocratici. 1. ed. Bompiani Il pensiero occidentale. Milano: Bompiani 2006.
9 Aristotele. Le tre etiche: testo greco a fronte. Milano: Bompiani 2008.
10 Natali C. Aristotle: his life and school. Princeton: Princeton University Press 2013.
11 Jaeger W. Aristotle’s Use of Medicine as Model of Method in his Ethics. J Hell Stud. 1957;77:54–61.
12 Fermani A. Vogliamo stare in salute piuttosto che sapere cosa significhi stare in salute – Riflessioni sulla vita sana, bella e buona, in dialogo con Aristotele. II Seminário Internacional – Filosofia e Saúde e IV Semana Dom Luciano Mendes. Faculdade Dom Luciano Mendes, Brasil 2021. https://www.youtube.com/watch?v=0yHgo-ylovY
13 Nussbaum M. La deliberazione non scientifica. La fragilità del bene. Fortuna ed etica nella tragedia e nella filosofia greca. Bologna: Il Mulino 2011.
14 Aristotele. Organon. I edizione Il pensiero occidentale. Milano: Bompiani 2016.
15 Fermani A. L’etica di Aristotele: il mondo della vita umana. 1. ed. Brescia: Morcelliana 2012.
16 Eskin C. Hippocrates, Kairos, and Writing in the Sciences. Rhetoric and Kairos: Essays in History, Theory, and Praxis. New York: State University of New York Press ( 2002:272.
17 Smith JE. Time and Qualitative Time. The Review of Metaphysics. 1986;40:3–16.
18 Frost Benedikt A. On Doing the Right Thing at the Right Time Toward an Ethics of Kairos. Rhetoric and Kairos: Essays in History, Theory, and Praxis. New York: State University of New York Press 2002:272.
19 Ianne M. Il cibo per la cura dell’anima, la musica e le virtù per la salute del corpo: kairos e epimeleia nella dottrina pitagorica. Thaumàzein | Rivista di Filosofia. 2023;11:19–39. doi: 10.13136/thau.v11i2.258
20 Stavru A, Capasso EG. Introduzione: Il kairos, le arti e le tecniche. Thaumàzein | Rivista di Filosofia. 2023;11:8–18. doi: 10.13136/thau.v11i2.280
21 Aristotele. Metafisica. II. Milano: Bompiani 2008.
22 Reale G. Guida alla lettura della ‘Metafisica’ di Aristotele. 1. ed. Bari: Laterza 1997.
[1] Scrive Helen King nel suo testo “Hippocrates now: the ‘father of medicine’ in the internet age” che ciò che sappiamo con certezza di lui si può ridurre alla seguente affermazione “Ippocrate visse nella Grecia classica ed è stato associato all’isola di Cos; si guadagnò una reputazione come scrittore e medico”, cioè veramente poco; tutte le altre informazioni che la tradizione riporta sarebbero interpretazioni a posteriori più o meno affidabili, ma spesso del tutto inattendibili [2].
[2] Inoltre, non mancano testimonianze di pratiche mediche ancora più antiche, in particolare di origine egizia. Tuttavia, così come si può cominciare a parlare di filosofia solo quando il pensiero greco si è separato da quelle che Reale definisce “credenze, culti religiosi, manifestazioni artistiche di varia natura, conoscenze e abilità tecniche di diverso tipo” [4], sancendo di fatto il passaggio dal regno del μίτος a quello del λόγος, allo stesso modo la medicina degli Egizi non riuscì ad “innalzarsi al di sopra di quella pratica di incantagioni e scongiuri che era ancora viva nell’antico costume della madrepatria greca” [1], fino a quando non si incontrò con l’innovativa considerazione universale, filosofica, della natura, inaugurata dal pensiero ionico.
[3] Basta aprire un qualunque testo di Filosofia della Scienza o di Filosofia della Medicina per rendersi conto di quante siano e quanto siano intricate queste relazioni, che qui tuttavia non approfondiremo; alcuni esempi sono le implicazioni etiche della professione medica (bioetica), la definizione dei concetti di salute e malattia, la metodologia della diagnosi, la ricerca ed i rapporti tra scienza e medicina, lo statuto delle malattie fisiche e mentali e così via.
[4] Come molti altri grandi filosofi del passato, Platone non sempre è un fedele narratore delle posizioni dei contemporanei. Spesso non si fa infatti remore ad utilizzarle strumentalmente per sostenere le proprie tesi, senza curarsi fino in fondo della loro ortodossia.
[5] Come sempre nella storia della filosofia antica, la certezza delle informazioni sulla vita degli autori è in forte dubbio. Diverse testimonianze sostengono comunque che Aristotele sarebbe rimasto orfano di padre intorno ai 14 anni e quindi affidato al tutore Prosseno, amico del padre (e forse anche di Platone), il quale l’avrebbe inviato presso l’Accademia al raggiungimento della maggiore età. Ciò spiegherebbe perché egli non abbia intrapreso, come abbiamo detto essere prassi, la professione paterna. Inoltre, secondo Plutarco, Aristotele avrebbe insegnato la medicina ad Alessandro e, secondo alcuni detrattori (gli epicurei in primis), l’avrebbe anche esercitata abusivamente… [10]
[6] Naturalmente la farmacologia contemporanea si è molto evoluta rispetto alla fitoterapia antica dei tempi di Aristotele, quando il rimedio andava preparato manualmente a partire dalla pianta (la ‘droga’); le moderne tecniche farmaceutiche consentono di avere dosaggi molto più standardizzati, che certamente non vanno bene per tutti, ma vanno bene per molti. La misura del giusto mezzo è oggi molto spesso ridotta alla valutazione del peso del paziente. D’altra parte, grazie alle più recenti tecniche immunologiche, si stanno sviluppando farmaci personalizzati (la cosiddetta ‘medicina di precisione’) che rinverdiranno questo concetto, al punto che già oggi abbiamo interventi immunoterapici che vanno bene esclusivamente per il singolo paziente per il quale sono stati preparati.
[7] In un altro senso, la potenza è invece anteriore all’atto secondo il tempo. Spiega Reale: “la priorità dell’atto secondo il tempo sussiste solo per quanto concerne la specie e non il singolo individuo. Infatti, l’individuo numericamente considerato è prima in potenza e poi in atto. Se si considera, invece, non il singolo, ma la serie degli individui, è prima l’individuo in atto, il quale genera un altro individuo facendolo passare dalla potenza all’atto.” [17 p.151]