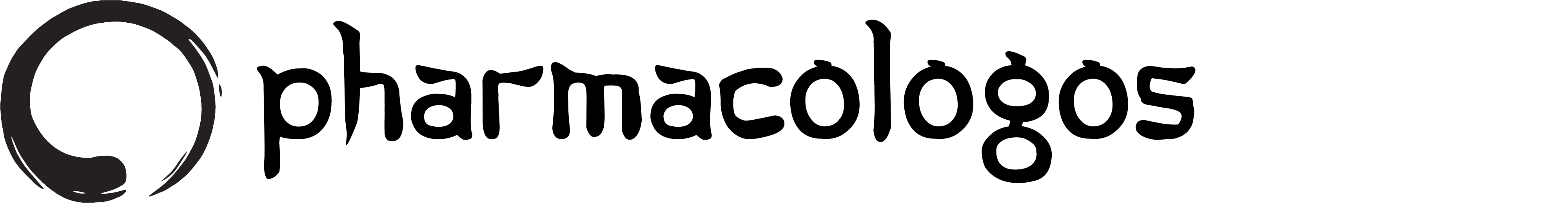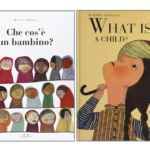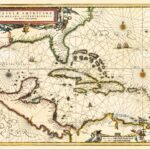Nel testo Psicopolitica (Han, 2016), Byung-Chul Han dipinge un quadro del neoliberismo come una politica incentrata sul controllo mentale che, invece di reprimerci, fa leva su libertà, desideri ed emozioni per spingerci all’auto-sfruttamento. Al tempo stesso, cerca di delineare possibili strade di resistenza e di liberazione, invocando forme di discontinuità o di negatività in grado di sfuggire alla logica totalizzante della trasparenza e della performance.
Dal Corpo alla Mente: Biopolitica e Psicopolitica
Byung-Chul Han è nato nel 1959 a Seul, dove ha iniziato i suoi studi in metallurgia per poi trasferirsi in Germania negli anni Ottanta. Qui si è dedicato alla filosofia, alla letteratura tedesca e alla teologia cattolica, ottenendo un dottorato a Friburgo con una tesi su Heidegger. In seguito, ha approfondito temi legati al neoliberismo e alla filosofia politica presso l’Università di Basilea, la Hochschule für Gestaltung di Karlsruhe e, dal 2012, come professore alla Universität der Künste di Berlino. Le opere di Han combinano il pensiero occidentale con principi del buddismo zen e del daoismo, proponendo una critica all’ossessione per la performance e all’eccesso di positività della società moderna. L’autore è noto per essere schivo e riservato, e spesso appare come una figura quasi ascetica nel panorama filosofico attuale. Questo atteggiamento si riflette anche nella struttura dei suoi testi, nei quali Han presenta in modo estremamente conciso e talvolta quasi aforistico la sua critica del neoliberismo come “potere intelligente”. In Psicopolitica in particolare, l’autore scandisce la sua riflessione in tredici brevi capitoli – meno di ventimila parole complessive – nei quali enuncia tesi forti, senza dilungarsi in dimostrazioni analitiche o citazioni bibliografiche.
Questa struttura saggistica veloce e provocatoria gli consente di condensare il suo pensiero in formule sintetiche e spesso apodittiche, sicuramente affascinanti, ma che a volte sembrano mancare di un contraddittorio o anche solo di una base fattuale dimostrabile.
Delineiamo in estrema sintesi la linea di pensiero dell’autore, prima di passare alla analisi di alcuni punti critici.
Fin dall’inizio del testo, Han osserva come la libertà, anziché contrapporsi al potere, finisca per diventarne paradossalmente uno strumento. Nel neoliberismo, infatti, il soggetto si percepisce come un “progetto libero”, capace di auto-realizzarsi, ma finisce in realtà per auto-sfruttarsi: in questo caso però la costrizione non è più imposta dall’alto, ma interiorizzata; questa sarebbe secondo Han anche la causa di disturbi psichici diffusi come depressione e burnout.
Secondo l’autore, il potere contemporaneo non agisce in maniera repressiva o violenta, ma, al contrario, seduce e motiva, facendo appello alla sfera emozionale e alla continua spinta all’auto-ottimizzazione. Questa nuova forma di potere si mostra apparentemente benevola e liberale, ma in realtà sfrutta proprio la libertà e la volontà individuali per ottenere il massimo controllo e il massimo rendimento.
Riprendendo una immagine foucaultiana (e la riflessione di Deleuze sulle società di controllo), Han individua due animali simbolo e li contrappone: la “talpa” della società disciplinare (che avanza in spazi chiusi, sottoposta a rigide regole) è sostituita dal “serpente” della società neoliberale, libero e flessibile ma, in verità, prigioniero di un sistema di controllo ben più sofisticato. Il serpente rappresenta in particolare il soggetto imprenditore di se stesso, che si illude di spostarsi senza vincoli, mentre il vincolo è assai più rigido di prima, ma è diventato invisibile, in quanto prettamente mentale. Secondo Han, infatti, la visione di Foucault incentrata sulla “biopolitica” (il governo dei corpi e delle popolazioni), non basta più a comprendere la realtà contemporanea: oggi, la produzione non è più solo industriale e materiale ma anche, e soprattutto, psichica. L’attenzione si è spostata quindi dalla amministrazione dei corpi (biopolitica) alla gestione degli stati mentali (psicopolitica).
Han denuncia inoltre l’ideologia dell’auto-ottimizzazione, diffusa nel neoliberismo: l’individuo è spinto a migliorarsi costantemente, in una logica quasi terapeutica (“guarire” da ogni negatività), ma così facendo rimane intrappolato in uno sforzo infinito che può annientarlo. Questo tentativo di “guarigione” si trasforma presto in una nuova forma di sfruttamento di sé.
Ma il punto centrale del testo di Han è quello relativo al “grande fratello benevolo” in cui si sarebbe trasformato il potere nel capitalismo digitale: a differenza dell’immagine orwelliana del Grande Fratello classico che controlla e reprime, il potere digitale appare amichevole, invita alla partecipazione e stimola continuamente a condividere dati, pensieri, emozioni, per ottenere in cambio qualche vantaggio. Ma è proprio questa dimensione volontaria a consentire l’accesso del sistema alla sfera più intima delle persone ed in ultima analisi ad amplificare la sorveglianza, che diviene quindi auto-sorveglianza.
Per ottenere questo effetto, la società contemporanea non sfrutta tanto (o almeno non solo) il lavoro fisico o intellettuale, ma si appropria soprattutto dei vissuti emotivi: sentimenti, desideri e relazioni diventano merci. I social network e il mercato digitale monetizzano l’intimità, trasformando la sfera affettiva in occasioni di profitto e di controllo. Un aspetto-chiave di questo processo è ad esempio la gamification sfruttata dal potere, che stimola la performance e la competitività continua: la logica del gioco si estende alla vita quotidiana (social, app, sfide e punteggi), spingendo l’individuo a divertirsi mentre produce dati, che in ultima analisi diventano valore per il sistema e strumento di potere e coercizione.
Al centro di questo apparato di potere digitale è la raccolta massiva di dati (tramite algoritmi, tracciamenti online, app di fitness, ecc.), i cosiddetti Big Data, che permettono un controllo ancor più capillare della psiche e dei comportamenti della popolazione. Secondo Han, attraverso l’analisi predittiva dei Big Data, il potere è in grado di anticipare desideri, scelte e decisioni, privando la libertà del suo spazio di possibilità.
Di fronte a questo scenario, Han segnala il rischio di smarrire ogni forma di soggettività autentica: il soggetto, ridotto a “impresa di se stesso”, si destruttura, non trova più un fondamento stabile e perde la possibilità di opporsi o di sottrarsi al sistema. Per questa ragione, in chiusura dell’opera, l’autore introduce il concetto di “idiotismo” come una forma di rinuncia attiva a partecipare alla corsa sfrenata della comunicazione e dell’ottimizzazione, un tentativo di preservare uno spazio interiore di resistenza. Una forma di eresia contro l’imperativo di essere sempre connessi e performanti.
Psicopolitica e Big Data: la Sorveglianza Algoritmica
Nel capitolo dedicato ai Big Data, Byung-Chul Han analizza il loro ruolo nella società contemporanea, mettendo in luce il passaggio da una sorveglianza disciplinare di tipo benthamiano a un controllo psicopolitico diffuso e pervasivo. Se il panopticon tradizionale era ancora limitato dalla prospettiva ottica, la sorveglianza digitale elimina ogni angolo cieco e penetra direttamente nella psiche degli individui. Questo nuovo regime di trasparenza assoluta si fonda su una vera e propria ideologia dei dati, che Han chiama Dataismo: una fede cieca nella capacità dei numeri di sostituire ogni forma di comprensione teorica. Secondo Han, in questa visione, tutto ciò che può essere misurato deve esserlo, e la conoscenza viene ridotta a correlazioni statistiche, senza più spazio per intuizione, teoria o narrazione.
Il Dataismo si presenta come un Secondo Illuminismo, che promette di liberare la conoscenza dal soggettivismo e dai pregiudizi ideologici, ma che in realtà si trasforma in un totalitarismo digitale fondato sulla trasparenza assoluta. In questo processo, il soggetto non solo si sorveglia da sé, ma contribuisce attivamente alla propria sottomissione attraverso pratiche di quantified self, registrando cioè dati sul proprio corpo e sulle proprie attività mentali nella convinzione di acquisire una maggiore consapevolezza di sé. Tuttavia, Han sostiene che questa ossessione per la misurabilità non produce autentica conoscenza: i numeri non raccontano nulla, non permettono un processo narrativo di costruzione del sé, ma frammentano l’identità in una somma di dati privi di senso.
L’uso dei Big Data non si limita alla sfera individuale, ma si estende al controllo sociale e politico. L’evoluzione del Web 3.0, con l’Internet delle Cose, consente di tracciare ogni azione umana, trasformando la vita in un’enorme memoria digitale dalla quale nulla può essere cancellato. Questo controllo si traduce anche in strumenti di micro-targeting che, attraverso l’analisi delle informazioni personali, influenzano direttamente le decisioni politiche e commerciali, rendendo la manipolazione ancora più sottile ed efficace. Han introduce quindi il concetto di inconscio digitale, paragonandolo all’inconscio ottico di Walter Benjamin: se la cinepresa rivelava dettagli invisibili all’occhio umano, i Big Data rivelano pattern di comportamento e desideri inconsci, permettendo al potere di intervenire a un livello più profondo e di condizionare le scelte senza che il soggetto se ne renda conto.
In questo scenario, l’essere umano stesso diventa merce. I dati personali vengono continuamente raccolti, venduti e utilizzati per classificare gli individui in base alla loro valenza economica, creando una nuova società digitale divisa in classi. Han descrive il passaggio dal panopticon al ban-opticon, un sistema che non si limita a sorvegliare, ma esclude chi è ritenuto inutile o poco redditizio, etichettando alcuni individui come spazzatura e negando loro l’accesso a servizi e opportunità.
Alla base di questa trasformazione vi è una concezione della memoria radicalmente diversa da quella umana. Mentre la memoria tradizionale è un processo narrativo in cui dimenticare è parte integrante del ricordare, la memoria digitale è pura accumulazione di dati: un archivio senza selezione e senza interpretazione. Han sottolinea come questo cambiamento cancelli il senso della storia e della soggettività, riducendo il sapere a una somma di correlazioni prive di profondità. I Big Data sembrano offrire una conoscenza assoluta, ma in realtà rappresentano un non-sapere assoluto: senza concetto, senza spirito, senza narrazione.
Infine, Han paragona l’entusiasmo per i Big Data all’euforia per la statistica nel XVIII secolo, un’epoca in cui si credeva che i numeri potessero rivelare il senso profondo della storia e persino la provvidenza divina. Tuttavia, questa illusione venne rapidamente smascherata dai romantici e da pensatori come Nietzsche, che vedevano nella statistica una forma di livellamento e conformismo. Anche oggi, il Dataismo ripropone per Han lo stesso errore, eliminando l’imprevedibilità, la singolarità e l’evento come elementi fondamentali della storia e della vita umana. In questo senso, i Big Data non solo rendono la società più prevedibile e uniforme, ma rischiano di condannarla a un’assenza di futuro, privandola della possibilità di qualsiasi vero cambiamento.
Dataismo, Manipolazione e Potere
Come abbiamo visto, Byung-Chul Han propone un’analisi molto critica dell’uso intensivo dei dati nella società contemporanea, evidenziandone i rischi di controllo e di riduzione della soggettività a un puro oggetto di misurazione. Il problema dell’uso dei dati a fini di controllo economico e più recentemente anche politico è sicuramente importante e sempre più centrale nella società contemporanea; tuttavia, alcuni passaggi del ragionamento di Han in questo contesto risultano problematici, eccessivamente semplificati o persino contraddittori.
1. Quantified Self e Identità: una Riduzione Possibile?
«La mera massa di dati così accumulata non risponde però alla domanda: Chi sono io? Anche il quantified self è una tecnica dadaista del Sé, che lo svuota completamente di senso. Il Sé è scomposto in dati fino al vuoto di senso.» (p.72)
Byung-Chul Han afferma che la raccolta di dati su di sé – attraverso dispositivi indossabili, app di fitness, tracciamenti biometrici o analisi comportamentali online – non fornisce alcuna risposta alla domanda esistenziale “Chi sono io?”. Questa affermazione, per quanto suggestiva, sembra confondere due piani di analisi molto diversi:
- La conoscenza di sé (riflessiva, narrativa, esistenziale), che riguarda valori, convinzioni, memoria autobiografica e significato personale.
- La misurazione di sé (autonoma e analitica), focalizzata sulla raccolta di parametri quantificabili (come frequenza cardiaca, glicemia, passi percorsi, pattern di navigazione o ore di sonno), gestita direttamente dal soggetto[1].
In realtà il cosiddetto quantified self non implica trasformare l’intera identità in numeri, bensì auto-tracciare aspetti circoscritti del proprio funzionamento (Swan, 2013). Sarebbe certamente un uso distorto pensare di sostituire la profondità del sé con un insieme di dati metrici: se ciò accadesse, si realizzerebbe davvero il rischio di svuotamento delineato da Han; tuttavia, nella grande maggioranza dei casi chi è dedito a questa pratica sfrutta le metriche per migliorare salute, abitudini quotidiane o efficienza, non per rispondere in modo più esauriente alla domanda “Chi sono io?”.
In questo senso, è l’etichetta “quantified self” a risultare ingannevole: non si sta quantificando la totalità del Sé, ma semplicemente monitorando, da soli, alcuni aspetti empirici della propria esperienza. Se è vero che l’ossessione per il dato potrebbe portare a riduzionismi, la maggior parte di queste pratiche nasce al contrario per arricchire la consapevolezza individuale, non certo per rimpiazzare la dimensione narrativa ed esistenziale della persona.
2. Misurare o Narrare: una Dialettica fra Dato e Racconto
«I numeri non raccontano nulla del Sé. Contare non è raccontare; il Sé, infatti, deriva da un racconto. Non il contare, ma il raccontare conduce alla scoperta o alla conoscenza di sé.» (p.72)
Qui Han individua una contrapposizione netta fra il conteggio (analisi quantitativa, registrazione meccanica) e il racconto (creazione di senso, narrazione autobiografica). Il fatto che “contare non sia raccontare” è indubbiamente vero: rilevare dati su di sé non equivale a elaborarli in una narrazione esistenziale. Al tempo stesso, non si capisce perché i due processi dovrebbero escludersi a vicenda. La componente narrativa resta sicuramente centrale per la costruzione dell’identità, tuttavia, l’acquisizione di dati può fornire informazioni utili che potrebbero arricchire la nostra comprensione di noi stessi o quantomeno esserci utili per svolgere meglio specifici compiti della vita quotidiana. I dati raccolti nell’ambito di un automonitoraggio possono benissimo essere interpretati inserendoli all’interno di un racconto più ampio (le proprie mete, le proprie relazioni, la propria storia e così via).
Il rischio da evitare non è tanto la registrazione di numeri con un auto-monitoraggio, quanto piuttosto l’eventuale “colonizzazione” del racconto da parte di una logica puramente quantitativa. Han corre il pericolo di scambiare un fenomeno parziale (una tendenza generale alla misurazione, probabilmente davvero nello zeitgeist della società contemporanea) con il destino ineluttabile di chiunque tracci i propri parametri fisiologici. Non credo che misurare alcune funzioni e dominii dell’essere ci impedisca l’elaborazione di un discorso narrativo sul Sé, anzi le due cose possono intrecciarsi e completarsi a vicenda.
3. È davvero possibile una replica digitale del Sè?
«Le nostre abitudini digitali offrono una copia esatta della nostra persona, del nostro animo, forse persino più precisa o completa dell’immagine che anche noi ci facciamo di noi stessi.» (p.73)
Se le affermazioni di Han fin qui citate sollevavano dubbi lasciando spazio a possibili interpretazioni alternative, su questo punto invece non è proprio possibile essere d’accordo. In alcuni passaggi, Han sembra attribuire ai dati un potere di mimesi totale dell’identità, che però è totalmente sconfessato dall’evidenza dei fatti. Appare assolutamente chiaro che i dati digitali non possono rappresentare la persona nella sua complessità, ma al massimo fornire tracce sbiadite di comportamenti (online e, in parte, offline). Avere uno storico di click, acquisti o preferenze sui social non si avvicina neanche lontanamente a conoscere l’interiorità dell’individuo. L’io narrante, il campo emotivo, la memoria e i significati che costruiamo attorno a ciò che facciamo non possono essere ridotti a un elenco di transazioni o navigazioni.
In tal senso, il nostro “io digitale” è soltanto una proiezione parziale, offuscata e caricaturale del nostro vero io: descrive sì qualcosa che ha a che fare con noi (interessi, tempi di fruizione, abitudini di spesa etc..), ma non possiamo assolutamente pensare che ci riproduca in toto. Parlare di “copia esatta” appare dunque un eccesso retorico, che sfiora il determinismo tecnologico e la tecnoparanoia. Continua infatti Han:
«Oggi, ogni nostro clic, ogni parametro di ricerca che immettiamo viene salvato. Ogni passo nella rete è osservato e registrato. La nostra vita si riflette completamente nella rete digitale.» (p.73)
Un quadro certamente inquietante, però niente affatto reale. Anche se molte azioni digitali vengono effettivamente memorizzate (alcuni clic, ricerche, interazioni social etc..), non si può dire che la vita intera di una persona sia “riflessa” online. Da un lato, numerosissimi aspetti restano totalmente al di fuori dalla rete (relazioni dirette, esperienze e pensieri non registrati), dall’altro, persino nei contesti più connessi, che pure generano e memorizzano molti dati (es. social network, motori di ricerca, app di messaggistica, e-commerce, servizi in cloud etc..), non viene affatto registrato ogni dettaglio, né l’intero contenuto dell’esperienza soggettiva. Ciò che appare online è, di fatto, un piccolissimo sottoinsieme frammentario di gesti o preferenze, da cui è impossibile anche solo avvicinarsi al vissuto integrale di una persona.
Anche quando si raccolgono enormi volumi di dati, questi rimangono solo tracce parziali: mostrano comportamenti, ricerche, acquisti, ma non abbracciano la complessità delle nostre relazioni, della nostra intimità o persino delle ragioni che ci spingono a compiere le azioni, le ricerche o i clic che sono stati tracciati. Di conseguenza, sebbene la digitalizzazione e l’archiviazione siano onnipresenti, la vita vera – fatta di pensieri, emozioni, conversazioni non registrate e ambiti offline – non coincide affatto con ciò che appare in rete.
Su questo argomento, mi trovo molto più in accordo con quanto sostiene il filosofo dell’informazione Luciano Floridi, il quale descrive l’infosfera come l’insieme complessivo dei processi informativi che caratterizzano il nostro ambiente: non solo i dati online, ma ogni flusso di conoscenza che attraversa reti, infrastrutture digitali e relazioni sociali (Floridi, 2017). All’interno di questa realtà sempre più pervasiva, l’essere umano sperimenta una condizione definita onlife, in cui online e offline non appaiono più nettamente separati: la nostra vita quotidiana risulta costantemente intrecciata con strumenti e ambienti digitali, e ciò finisce per influenzare anche i modi di percepirci e di rapportarci con gli altri (Floridi, 2015).
Tuttavia, pur considerando la rilevanza della dimensione onlife, ciò non significa che i dati registrati online possano produrre una “copia esatta” dell’identità personale. La pervasività dell’infosfera non implica la possibilità di tracciare tutto ciò che siamo: gli infiniti gesti, pensieri, emozioni e relazioni offline rimangono in larga parte fuori dal raggio di qualunque registrazione o analisi statistica. I processi digitali hanno certamente un impatto profondo sulle nostre vite, ma non sino al punto di rimpiazzare la complessità dell’esperienza umana: l’“io digitale” che emerge dalle tracce online è soltanto un riflesso parziale dell’individuo, non un suo duplicato esaustivo (Floridi, 2017).
In tale prospettiva, la condizione onlife implica sì che siamo (quasi) costantemente connessi, ma non annulla la nostra sfera intima e inaccessibile all’algoritmo. Dati biometrici, cronologie di navigazione e interazioni sui social forniscono alcune informazioni su di noi, ma affidarsi ciecamente a questi dati per delineare la persona equivarrebbe a ridurne la ricchezza irripetibile a un inventario di parametri. Piuttosto che considerare la vita online come una copia integrale dell’identità, occorre riconoscere che l’infosfera dischiude nuove opportunità di comprensione e relazione, ma non esaurisce il nostro Sé: rimangono sempre dimensioni sottratte alle metriche e al controllo totale.
4. La Memoria Digitale Totale: Iperbole o Minaccia Reale?
«Il web 3.0 rende possibile protocollare l’intera vita. Siamo sorvegliati, ora, anche dalle cose che utilizziamo quotidianamente. Siamo per così dire imprigionati nella memoria totale di natura digitale.» (p.74)
Come detto, Byung-Chul Han sostiene che l’era digitale ci ha intrappolati in una sorta di panottico invisibile, dove la sorveglianza non è più imposta dall’alto ma interiorizzata dagli individui stessi, spingendoli a esibirsi e auto-monitorarsi volontariamente. C’è però da dire che in questo panottico digitale la sorveglianza è distribuita, frammentata, ma spesso anche contestata; non siamo infatti semplici soggetti passivi di un potere onnisciente, in quanto esistono ampi spazi di anonimato, strumenti di protezione della privacy e un contesto legale internazionale che limita il potere di controllo. Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) in Europa ha introdotto ad esempio principi di trasparenza, diritto all’oblio e limiti alla profilazione automatizzata (Unione Europea, 2016), mentre l’American Privacy Rights Act (Wikipedia, 2025a) e altre normative in tutto il mondo stanno cercando di restituire agli utenti il controllo sui loro dati personali.
Certo, l’uso dei dati personali da parte di grandi piattaforme digitali solleva importanti interrogativi etici e richiede un monitoraggio costante da parte delle istituzioni e degli utenti stessi. Ma il rischio non è tanto quello di essere “imprigionati” nella memoria digitale, quanto piuttosto quello di non esercitare consapevolmente il nostro diritto a gestire la nostra identità digitale. L’iperbole di Han può servire da monito, ma non descrive fedelmente la realtà: non ci troviamo tanto in un carcere invisibile, quanto in un ambiente che richiede alfabetizzazione digitale e strumenti adeguati per riuscire a navigarlo in modo autonomo e critico.
5. Micro-targeting e statistica
«Si ricorre al micro-targeting per rivolgersi ai votanti in modo mirato, con messaggi personalizzati, per influenzarli. Il micro-targeting come prassi della microfisica del potere è una psicopolitica basata sui dati.» (p.74)
Han descrive il micro-targeting come un meccanismo di controllo estremamente personalizzato, capace di monitorare il singolo individuo e condizionarlo su misura. Si tratta anche in questo caso di una esasperazione: nella realtà, le piattaforme pubblicitarie (da Google a Facebook) lavorano soprattutto su campioni e segmenti di popolazione, categorizzando gli utenti in cluster statistici. Non si tratta di un Io contro un Grande Fratello che scruta le mie singole mosse, bensì di algoritmi che associano preferenze e pattern di comportamento in modo probabilistico. In questo senso, il micro-targeting non può compiere un’analisi psicologica approfondita del singolo, ma si basa piuttosto su ipotesi condivise da gruppi di utenti simili per età, abitudini d’acquisto, ricerche online, interessi dichiarati e così via.
Il rischio di manipolazione certamente esiste, ma non è corretto parlare di un “monitoraggio del singolo” come se un potere centralizzato “leggesse la mente” di ciascun utente. Il micro-targeting è più vicino a un’operazione di segmentazione di massa, efficiente su grandi numeri ma tutt’altro che infallibile sul singolo.
Ho sempre pensato che le possibilità di “prevedere il comportamento” attribuita ai Big Data somigliassero a quelle della “psicostoria” immaginata nel secolo scorso da Isaac Asimov[2]. Nei romanzi di fantascienza di Asimov, la psicostoria è una scienza fittizia che combina storia, sociologia, matematica e statistica per prevedere il comportamento di vaste popolazioni su scala galattica. La disciplina si basa su alcuni presupposti fondamentali: la necessità di una popolazione estremamente numerosa affinché le previsioni siano accurate; l’ignoranza collettiva riguardo alle analisi psicostoriche (poiché la consapevolezza di essere analizzati potrebbe alterare i comportamenti e invalidare le previsioni); l’assenza di influenze esterne significative, come entità soprannaturali o agenti non-umani, che potrebbero compromettere l’accuratezza dei calcoli statistici. Nella visione del suo inventore, la psicostoria poteva anticipare molto bene le tendenze generali delle masse, ma non era in grado di prevedere le azioni di singoli individui. Asimov (che di estrazione era un professore di Biochimica all’Università di Boston) utilizzava spesso l’analogia con la teoria cinetica dei gas: sebbene sia totalmente impossibile prevedere il movimento delle singole molecole di un gas a causa dei continui urti casuali con altre molecole, il comportamento collettivo del gas può essere descritto con una precisione piuttosto buona tramite leggi statistiche (Siegfried, 2006, p. 126).
Contrariamente alla visione di Han, la mia impressione è che i Big Data di oggi operino in maniera simile alla psicostoria di Asimov: non sono in grado (né hanno bisogno) di scandagliare la psiche di ogni singolo utente, ma si concentrano sull’individuazione di pattern statistici all’interno di grandi popolazioni. In modo analogo a quanto descritto dalla teoria cinetica dei gas, nel micro-targeting le piattaforme basate su Big Data non “leggono la mente” individuale, bensì tipizzano gruppi di utenti accomunati da caratteristiche similari (età, interessi, abitudini d’acquisto etc…). Successivamente, operazioni di marketing e propaganda correlate a questi dati indirizzano messaggi mirati a tali segmenti, con un’efficacia che cresce al crescere della mole di dati analizzata. Risulta quindi verosimile che si possa manipolare in misura non trascurabile l’orientamento di grandi masse, ma non c’è alcuna forma di “monitoraggio puntuale” capace di controllare le scelte di un singolo individuo in modo infallibile.
È chiaro che anche un simile approccio probabilistico non è affatto privo di rischi: la statistica di gruppo può influenzare in maniera estesa i comportamenti collettivi e alimentare pericolose asimmetrie informative. Tuttavia, parlare di un “potere assoluto” che sgretola la libertà individuale e accede alla psiche dell’individuo appare decisamente un’iperbole. È vero che ci troviamo di fronte a dispositivi tecnologici sofisticati, capaci di maneggiare enormi volumi di dati in tempo reale, ma il loro fulcro rimane la stima di probabilità aggregate, non la lettura profonda dei pensieri o delle emozioni di ogni singola persona. In questo senso, se il pericolo di manipolazione esiste, la sua natura è essenzialmente “di massa”: si bersagliano gruppi di utenti sulla base di correlazioni statistiche, lasciando aperte ampie zone d’ombra che la macchina predittiva, per quanto avanzata, non riesce e non riuscirà mai a illuminare.
6. “Inconscio digitale” e Accesso alla Psiche
«I Big Data rendono leggibili, forse, i nostri desideri, dei quali noi stessi non siamo espressamente coscienti. In effetti, in determinate circostanze sviluppiamo inclinazioni che si sottraggono alla nostra coscienza; spesso non sappiamo neppure perché all’improvviso compare in noi un certo bisogno. Il fatto che una donna, in una certa settimana della gravidanza, desideri un determinato prodotto, implica una correlazione della quale lei stessa non è cosciente. Compra semplicemente quel prodotto, ma non sa perché. È cosí. Questo “esser-cosí” ha forse una prossimità psichica con l’Es freudiano, che si sottrae all’Io cosciente.» (p. 75-76)
Han parla di un “inconscio digitale” reso leggibile dai Big Data, come se gli algoritmi potessero entrare nei recessi più profondi della psiche umana. Ma la realtà è molto meno esoterica: abbiamo detto che gli algoritmi rilevano correlazioni tra abitudini, preferenze di consumo, clic e ricerche, ma non “leggono la mente”, né penetrano gli strati inconsci della personalità. Certo, possono emergere dai dati pattern di cui noi, come singoli, non eravamo consapevoli (ad esempio preferenze di acquisto che non avevamo razionalizzato), ma parlare di “desideri inconsci” in termini psicoanalitici rischia di confondere la statistica con il regno pulsionale e simbolico dell’essere umano. È quindi eccessivo affermare che il Dataismo sveli “l’Es freudiano”, anche se si tratta chiaramente di un linguaggio metaforico, il suo uso rischia di attribuire all’analisi dei dati un potere quasi mistico.
Restando all’esempio di Han, se una donna in una determinata settimana di gravidanza desidera un certo prodotto che è stato acquistato da altre donne nello stesso periodo della gravidanza, è molto probabile che ciò dipenda da una dinamica sociale e culturale semplice e ben più accessibile della psicoanalisi. Quel prodotto è stato ritenuto utile da molte persone in quella situazione; quindi viene proposto ad altre persone nella medesima situazione, con una probabilità di acquisto superiore (e quindi un risparmio di risorse) rispetto al proporlo a tappeto a tutta la popolazione; questo processo si inserisce in un circolo di ripetizione e rinforzo, che gli algoritmi di raccomandazione amplificano fortemente. La pubblicità personalizzata non svela tanto i nostri desideri inconsci (ai quali non può avere accesso), ma sfrutta piuttosto la ripetizione e l’autorità del numero per rendere certi prodotti più appetibili.
Certo, anche in questo caso il rischio di manipolazione è molto alto: se una persona vede continuamente suggerito un prodotto, è portata a crederlo essenziale, anche se la sua utilità non è oggettiva. Questo non significa, tuttavia, che gli algoritmi stiano “rivelando pulsioni profonde”, bensì che stanno modellando preferenze attraverso l’esposizione e la ripetizione. L’“inconscio digitale” di Han, dunque, è una sovrainterpretazione. Più che un Es che si rivela a se stesso, quello dei Big Data sembra essere un Ego che viene addestrato attraverso un ambiente informativo costruito ad hoc. La questione, allora, non è psicoanalitica, ma sociologica: la sfida principale diventa quella di preservare il libero arbitrio e il discernimento critico in un contesto di esposizione algoritmica costante.
7. Big Data Onniscienti o Ciechi? Le Contraddizioni di un Paradigma
Come abbiamo visto, Han attribuisce ai Big Data, in alcuni passaggi, un potere quasi onnisciente, sostenendo ad esempio che:
«Se i Big Data dessero accesso al regno inconscio di azioni e inclinazioni, allora sarebbe pensabile una psicopolitica capace di innestarsi in profondità nella nostra psiche e di sfruttarla.» (p.76)
Egli suggerisce che l’analisi di correlazioni estese potrebbe leggere desideri o bisogni inconsci, fino a intervenire nei processi mentali senza che il singolo ne sia consapevole. Tuttavia, in altre pagine ammette apertamente che l’evento singolare e la dimensione creativa o imprevedibile dell’umano restano fuori dal raggio d’azione di qualsiasi approccio statistico-probabilistico:
«I Big Data rendono visibili soprattutto i modelli di comportamento collettivo […] Il data-mining non si distingue nella sostanza dalla statistica. Le correlazioni, che esso scopre, rappresentano ciò che è statisticamente probabile. Si calcolano valori medi statistici; così, i Big Data non hanno alcun accesso a ciò che è unico. I Big Data sono completamente ciechi agli eventi. La storia, il futuro umano non sono determinati dalla probabilità statistica, ma dall’improbabile, dal singolare, dall’evento. Così, i Big Data sono anche ciechi verso il futuro. (p.89-90)
Ne emerge una doppia postura: da un lato, l’idea che i dati possano arrivare a “possedere” l’essere umano nei suoi meccanismi più reconditi; dall’altro, la consapevolezza che la vera novità — l’“improbabile” e il “singolare” — resterebbe indecifrabile per una tecnica che, per definizione, opera su correlazioni generali e pattern ripetuti. Queste due tesi, pur coesistendo nello stesso capitolo, non vengono armonizzate in un quadro coerente. Infatti, se è plausibile immaginare una psicopolitica capace di influenzare bisogni e desideri subconsci, come conciliarla con l’incapacità dei Big Data di prevedere o cogliere l’evento inatteso?
In chiusura del capitolo, Han sottolinea correttamente che i Big Data non riescono a individuare «l’improbabile, il singolare, l’evento» (p.85), cosa che li rende di fatto «ciechi verso il futuro.» (p.85), ma allo stesso tempo aveva poco prima descritto un’analisi algoritmica in grado di arrivare a «desideri che noi stessi non siamo espressamente coscienti di avere» (p.75), concetto che presuppone invece una sorveglianza profonda sul singolo.
Il risultato è, appunto, una tensione irrisolta fra l’idea di un controllo digitale pressoché totale e il riconoscimento esplicito dei limiti intrinseci di qualunque strumento statistico di fronte alla creatività e all’imprevedibilità umane.
Conclusioni: spazi di libertà nell’era del determinismo tecnologico
In conclusione, il quadro tracciato da Han mette l’accento su rischi e derive molto reali: l’ossessione per la misurabilità, la trasparenza totale che elide la privacy, la tentazione di ridurre la complessità umana a nuda correlazione statistica. Tuttavia, la sua lettura a tratti estremizza tali fenomeni, configurando un potere digitale pressoché onnipotente e individui sempre più vittime passive.
Se ciò serve sicuramente a sollevare un segnale di allarme, allo stesso tempo rischia di oscurare le sfumature di un contesto che, invece, ammette ancora molti spazi di negoziazione, creatività e persino resistenza.
È dunque necessario tenere insieme due esigenze: riconoscere i limiti di qualunque quantificazione e statistica nel descrivere l’interiorità umana e insieme non sottovalutare i pericoli di un uso distorto e massivo dei dati, che può alterare dinamiche politiche, economiche e sociali.
Se da un lato Han ci ricorda che la società digitale può sfociare in forme di psicopolitica pervasive, dall’altro non possiamo ignorare che esistono ancora ampi margini per un uso consapevole dei dati, tutele normative e possibilità di narrazione e di critica.
È proprio in questo equilibrio tra vigile attenzione e rifiuto del determinismo tecnologico che si può probabilmente collocare l’approccio più efficace per comprendere, e magari governare meglio, la trasformazione digitale in corso nella società contemporanea.
Bibliografia
Floridi, L. (ed.) (2015) The Onlife Manifesto. Cham: Springer International Publishing. Available at: https://doi.org/10.1007/978-3-319-04093-6.
Floridi, L. (2017) La quarta rivoluzione: Come l’infosfera sta trasformando il mondo. Raffaello Cortina Editore. Available at: https://books.google.al/books?id=b6MCEAAAQBAJ.
Han, B.-C. (2016) Psicopolitica. Il neoliberismo e le nuove tecniche del potere. Nottetempo.
Siegfried, T. (2006) ‘Quetelet’s Statistics and Maxwell’s Molecules–Statistics and society, statistics and physics’, in A Beautiful Math: John Nash, Game Theory, and the Modern Quest for a Code of Nature. Washington, DC: The National Academies Press. Available at: https://doi.org/10.17226/11631.
Swan, M. (2013) ‘The Quantified Self: Fundamental Disruption in Big Data Science and Biological Discovery’, Big Data, 1(2), pp. 85–99. Available at: https://doi.org/10.1089/big.2012.0002.
Unione Europea (2016) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE. Available at: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/2016-05-04/ita (Accessed: 23 February 2025).
Wikipedia (2025a) ‘American Privacy Rights Act’, Wikipedia. Available at: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=American_Privacy_Rights_Act&oldid=1270556175 (Accessed: 23 February 2025).
Wikipedia (2025b) ‘Foundation’, Wikipedia. Available at: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Foundation_(book_series)&oldid=1275872482 (Accessed: 23 February 2025).
[1] Per la precisione, nel significato originale in cui il termine è nato, “self-quantification” non significa “misurazione del sé”, ma più prosaicamente “misurazione da sé”, nel senso di misurare qualcosa “da soli” tramite un device o una app, senza bisogno dell’intervento di un operatore esterno.
[2] Isaac Asimov (1920-1992) è stato un prolifico scrittore nato in Russia e naturalizzato statunitense, noto per le sue opere di fantascienza e divulgazione scientifica. Ha introdotto il concetto di “psicostoria” nei racconti della serie “Fondazione”, pubblicati tra il 1942 e il 1944 sulla rivista Astounding Science Fiction, successivamente raccolti nella cosiddetta Trilogia della Fondazione a partire dal 1951. Asimov ha poi ampliato questo concetto attraverso un ciclo di sette romanzi, noto come Ciclo della Fondazione, che include prequel e sequel della trilogia originale (Wikipedia, 2025b).