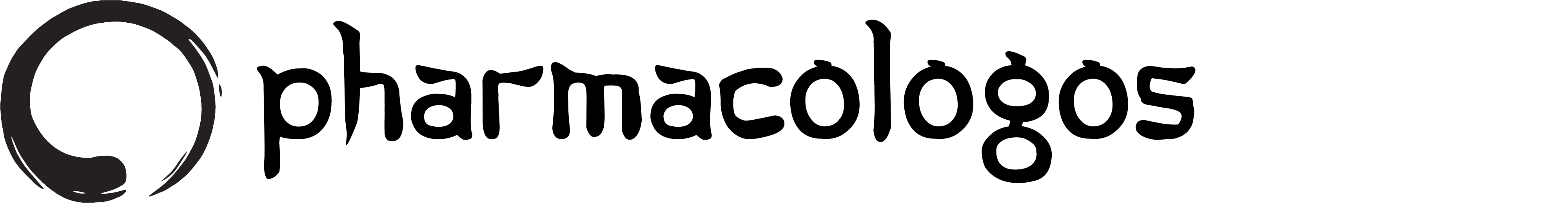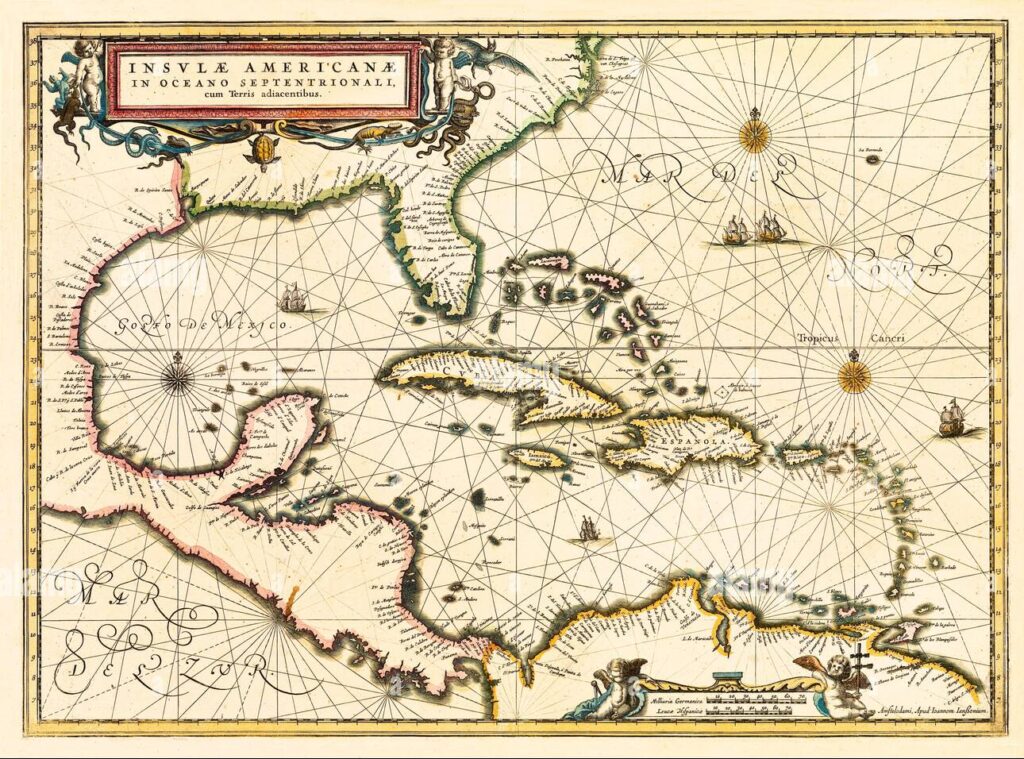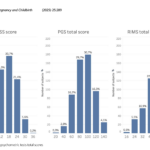Rinominare il mondo: il potere di ridefinire la realtà
Il 20 gennaio 2025, nel primo giorno del suo secondo mandato, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per rinominare il Golfo del Messico in “Golfo d’America” (El País, 2025a), cancellando il nome in uso dal 1540 presso tutti gli organismi internazionali. L’atto non è certamente neutro: la denominazione originale era profondamente radicata nella storia e nella cultura dei popoli centroamericani e rappresenta da secoli un elemento chiave dell’identità nazionale di diversi paesi, in particolare del Messico. Cambiare nome ad un elemento geografico di tale rilevanza comporta importanti implicazioni a livello diplomatico, per le carte nautiche, per i documenti legali e per le convenzioni internazionali che regolano la navigazione in quelle acque. Inoltre, una modifica del genere non può non influenzare le relazioni commerciali e politiche tra gli Stati Uniti e i paesi confinanti, sollevando questioni sulla sovranità e sul rispetto dei trattati internazionali (Goodwin, 2025).
La mossa di Trump, preannunciata prima dell’inizio del mandato, ha inizialmente sollevato perplessità e ilarità, sembrando più che altro una delle tante boutade a cui il tycoon aveva ampiamente abituato. Ma in realtà (e piuttosto inaspettatamente), nel giro di poche settimane giganti tecnologici come Google e Apple hanno rapidamente aggiornato le loro applicazioni di mappe per riflettere la nuova denominazione. Google Maps ha annunciato che negli Stati Uniti il Golfo sarà indicato come “Golfo d’America”, mentre nel resto del mondo saranno utilizzati entrambi i nomi (ANSA, 2025); Apple Maps ha subito seguito l’esempio, implementando intanto la nuova denominazione per gli utenti statunitensi (Geopop, 2025).
D’altra parte, al di fuori degli Stati Uniti, come prevedibile, la mossa ha invece incontrato resistenze significative: ad esempio la presidente del Messico ha ironizzato sulla proposta, sottolineando l’inappropriatezza della scelta, data l’interdipendenza economica tra i due paesi e la storicità del nome (El País, 2025a). Inoltre, anche all’interno degli USA sono state manifestate importanti resistenze: l’agenzia di stampa Associated Press ha rifiutato di adottare la nuova denominazione, continuando a utilizzare “Golfo del Messico” nei suoi reportage. In risposta, il presidente Trump ha emesso un divieto indefinito che impedisce ai giornalisti dell’agenzia di accedere agli eventi stampa nella Casa Bianca, inclusi quelli nello Studio Ovale e a bordo dell’Air Force One, sollevando serie preoccupazioni riguardo alla libertà di stampa e all’accesso dei media alle informazioni governative (El País, 2025b).
Trump e Musk: una partita di potere tra politica ed economia
Facendo un passo indietro alla campagna presidenziale del 2024, un ruolo cruciale nel sostenere la rielezione di Donald Trump è stato svolto da Elon Musk, imprenditore sudafricano che ha costruito la sua immensa fortuna attraverso una combinazione di speculazioni finanziarie e idee innovative (tra i suoi successi più noti figurano PayPal e Tesla, che hanno rivoluzionato rispettivamente i settori dei pagamenti online e delle auto elettriche), ma che è anche al centro di dibattiti per progetti controversi, come Neuralink, che mira a sviluppare interfacce neurali impiantabili, e SpaceX, una azienda dalle ambiziose mire colonialistiche su Marte. La carriera imprenditoriale di Musk è iniziata con Zip2, una società di software venduta nel 1999 per oltre 300 milioni di dollari. Successivamente, ha co-fondato X.com, una piattaforma di servizi finanziari online, che in seguito è diventata PayPal. La vendita di PayPal a eBay nel 2002 per 1,5 miliardi di dollari ha fruttato a Musk circa 165 milioni di dollari. Questi fondi sono stati reinvestiti in nuove iniziative, tra cui Tesla e SpaceX. Nel 2024, il patrimonio netto di Musk ha superato i 400 miliardi di dollari, rendendolo una delle persone più ricche al mondo di sempre (Forbes, 2025). Un esempio spesso citato per illustrare l’enormità del suo patrimonio è questo: se qualcuno avesse iniziato a guadagnare 10.000 dollari al giorno dalla costruzione della Grande Piramide di Giza, circa 4.500 anni fa, oggi avrebbe accumulato a malapena il 6% della ricchezza di cui egli dispone.
Nel corso della campagna presidenziale del 2024, Elon Musk ha svolto un ruolo cruciale nel sostenere la rielezione di Donald Trump. Inizialmente, Musk aveva espresso riserve sulla candidatura del tycoon, ma, soprattutto dopo il tentativo di assassinio del luglio 2024, la sua posizione è cambiata, ha dichiarato pubblicamente il sostegno a Trump ed è diventato il più grande donatore individuale delle elezioni del 2024, attraverso il Super PAC da lui fondato (oltre 260 milioni di dollari di donazione) (Matthews, 2024).
In aggiunta al sostegno finanziario, Musk ha ampiamente utilizzato la sua piattaforma X per dare risonanza alle posizioni più radicali del movimento trumpiano “Make America Great Again” (MAGA), una collaborazione che ha sollevato preoccupazioni riguardo alla possibile influenza dell’imprenditore sulle politiche governative e sui potenziali benefici per le sue numerose aziende.
Nell’ottobre 2022, Musk aveva infatti acquisito Twitter, il primo e più iconico dei social network, per 44 miliardi di dollari e, in una mossa audace, solo pochi mesi dopo aveva rinominato la piattaforma in “X”, sfidando le convenzioni tradizionali del marketing e andando a modificare un marchio ampiamente consolidato a livello globale e ampiamente considerato tra i più riconoscibili al mondo (Wikipedia, 2023). Nel 2024 X è diventato un hub centrale per le comunicazioni ufficiali del governo e per la campagna di Trump.
Linguaggio e potere: il dominio attraverso le parole
Nell’Excursus I, della Dialettica dell’Illuminismo di Horkheimer e Adorno la figura di Odisseo incarna l’individuo borghese nascente, capace di dominare la natura e gli altri esseri umani attraverso la razionalità strumentale. Il suo viaggio è un processo di autoaffermazione che implica il distacco dal mito e la capacità di manipolare il mondo attraverso l’astuzia e l’inganno (Horkheimer and Adorno, 1947). Tuttavia, gli autori sostengono che l’Illuminismo, nel suo sforzo di razionalizzare il mondo, ha finito per riprodurre le stesse dinamiche di dominio che voleva superare; in questa ottica, la funzione del linguaggio in particolare risulta centrale: molto spesso non serve più a comunicare, bensì ad esercitare il potere ed a consolidare il dominio sugli altri membri della società borghese.
Se il pensiero di tipo “illuminista” ha sempre avuto l’ambizione di liberare l’umanità dalle catene del mito e dell’ignoranza, nella sua evoluzione storica ha finito per trasformare il linguaggio in uno strumento di controllo e manipolazione, funzionale alla riproduzione della società borghese.
Per Horkheimer e Adorno, l’episodio delle Sirene nell’Odissea ne è una chiara rappresentazione simbolica: il linguaggio, incarnato dal canto ammaliante delle creature mitiche, è separato dall’esperienza diretta e diventa un oggetto da ascoltare passivamente. Odisseo, che vuole godere del canto senza subirne le conseguenze, si fa legare all’albero della nave, mentre i suoi compagni, resi temporaneamente sordi dalla cera nelle orecchie, remano senza poter comprendere. Questa scena è emblematica di un più ampio processo di reificazione del linguaggio, in cui la parola non serve più a comunicare esperienze autentiche, ma viene svuotata della sua forza espressiva e trasformata in un dispositivo di potere.
Il linguaggio, nella società moderna, non è più un mezzo per esprimere un rapporto autentico con il mondo, ma diventa un codice operativo, un sistema di segni funzionali alla gestione e all’organizzazione della realtà sociale ed economica. L’individuo non parla per comprendere, ma per classificare, denominare e, soprattutto, controllare. Questa trasformazione è evidente nei linguaggi specialistici, nella burocrazia e nella politica, dove le parole perdono il loro valore originario e servono unicamente a consolidare rapporti di potere preesistenti.
Ancora Adorno, in Minima Moralia, parla di un “isolamento per comunicazione”, per cui più il linguaggio si diffonde attraverso i media, più gli individui sono separati da una vera esperienza di dialogo e reciprocità (Adorno, 1954). Le informazioni vengono trasmesse, ma senza la possibilità di rispondere, generando un effetto di alienazione simile a quello dei compagni di Odisseo, che partecipano all’evento senza poterne comprendere il senso.
In particolare, Horkheimer e Adorno criticano esplicitamente il modo in cui il linguaggio moderno viene sfruttato dalla propaganda e dall’industria culturale, ogni opposizione viene disinnescata e convertita in un prodotto di consumo. Proprio come il canto delle Sirene è irresistibile, ma porta alla rovina, così il linguaggio pubblicitario e politico si presenta come seducente, ma ha lo scopo di modellare il comportamento umano e creare bisogni artificiali.
Sia dal punto di vista tecnico che da quello economico la pubblicità e l’industria culturale si fondono fra di loro. Nell’una come nell’altra la stessa cosa appare in luoghi innumerevoli, e la ripetizione meccanica dello stesso prodotto culturale è già quella dello stesso slogan propagandistico. Nell’una come nell’altra, sotto l’imperativo dell’efficienza operativa, la tecnica diventa psicotecnica, tecnica della manipolazione degli esseri umani. Nell’una come nell’altra valgono le norme di ciò che dev’essere sorprendente e tuttavia familiare, di ciò che dev’essere facile e leggero e tuttavia penetrante e incisivo, di ciò che dev’essere esperto e qualificato e tuttavia semplice e banale; si tratta sempre di trovare il modo di soggiogare e conquistare il cliente, che ci si rappresenta come distratto o riluttante a lasciarsi indirizzare come si deve. (Horkheimer and Adorno, 1947, p. 177)
Oggi più che mai, il linguaggio della società capitalistica è simile a quello della pubblicità: non mira affatto alla ricerca della verità, quanto piuttosto alla persuasione e alla riproduzione dei rapporti di potere.
Se trasponiamo infatti questa analisi al presente, Trump e Musk utilizzano il linguaggio in modo simile a come ce lo presentano i due fondatori della Scuola di Francoforte:
- Musk ha rinominato Twitter in X con un’operazione che rientra nella sua tendenza a destrutturare e ridefinire i simboli consolidati per imporre la propria visione. Proprio come Odisseo trasforma il mito per il proprio vantaggio, Musk ha trasformato uno dei più importanti simboli della comunicazione contemporanea, snaturandolo per esercitare un controllo psicopolitico. Il brand Twitter, per quanto conosciuto, ricco e ‘potente’, non esprimeva infatti il potere di Musk, ma forse più quello di Jack Dorsey (il suo fondatore originale). Prendere un prodotto leader al mondo, rinominarlo, decolorarlo e ribrandizzarlo (da un azzurro uccellino che cinguetta, ad una banale X maiuscola bianca su sfondo nero), non è stata tanto una operazione commerciale, quanto un esercizio di potere: il potere di Musk sopra il marchio, sopra Dorsey, sopra il mercato e sopra addirittura le regole del mercato, che dicono che cancellare il brand più noto del mondo difficilmente può essere una buona idea [1]….
- Trump dal canto suo arriva a rinominare addirittura il Golfo del Messico. E non lo ha fatto perché questa operazione abbia un reale significato o una specifica funzione politica o amministrativa[2], lo ha fatto soprattutto per affermare un primato, il primato statunitense, certo, cancellando simbolicamente la sovranità del Messico e riscrivendo la realtà a fini politici, ma soprattutto il suo primato personale: sulla geografia, sulla storia, sulla politica, sul protocollo (chi l’ha detto che un atto presidenziale firmato col pennarello a favore di camera può davvero cambiare il nome di un golfo?) e infine forse anche sul suo sodale e finanziatore sudafricano, come per dire: “con tutti i tuoi soldi, tu non sei stato capace di far accettare il cambiamento del nome di un mero social network, io cambio addirittura il nome di un golfo e tutti mi devono venire dietro”. Questo è il vero potere simbolico, una forma di manipolazione che non ha più neanche bisogno di essere razionale, ma solo efficace nell’imporre una nuova narrazione.
Seguendo Horkheimer e Adorno, la manipolazione linguistica appare quindi come una forma moderna di dominio che si presenta sotto le spoglie della libertà e dell’innovazione, ma che in realtà riproduce il meccanismo dell’asservimento. In questi esempi, né Trump, né Musk impongono il loro potere con la repressione diretta, ma oggettivamente esercitano una manipolazione simbolica che rende difficile pensare alternative. Il rebranding linguistico appare come una forma di dominio che ricorda la razionalità strumentale di Odisseo: un potere che non si impone esplicitamente con la violenza, ma si esercita attraverso l’uso strategico del linguaggio, l’astuzia, l’inganno e la manipolazione simbolica.
Trasgredire per comandare: la spettacolarizzazione del potere
Oltre alla manipolazione linguistica, Horkheimer e Adorno ci suggeriscono che il potere moderno non sfrutta più soltanto la coercizione diretta, ma anche e soprattutto la spettacolarizzazione e la manipolazione di quella che loro chiamano “industria culturale”. L’industria culturale non si limita a intrattenere, ma ha la funzione di normalizzare e legittimare i rapporti di dominio, trasformandoli in spettacolo e in consumo di massa. In questa logica, anche la violazione delle norme e dei protocolli, quando è voluta, manifesta ed esibita pubblicamente, non può essere considerata un atto sovversivo, ma diventa parte integrante della messa in scena del potere stesso.
Nel teatro del potere, anche la trasgressione delle regole è divenuta funzionale al rafforzamento dello status quo: permette ai leader di affermare il proprio potere non tanto rispettando le istituzioni, quanto al contrario ridicolizzandole e sovvertendole a proprio piacimento.
È in questo contesto che possiamo leggere uno degli ultimi episodi che hanno visto Elon Musk protagonista, ancora in relazione al suo rapporto col presidente Trump, lo scorso 11 febbraio, quando si è presentato ad una conferenza stampa alla Casa Bianca in una t-shirt e con il cappellino MAGA (quando il protocollo presidenziale prevede giacca e cravatta per questi eventi) ed accompagnato da suo figlio di 4 anni X Æ A-Xii, soprannominato “Lil X” (Glamour, 2025). Il bambino è uno dei dodici figli riconosciuti del magnate ed ha attirato l’attenzione pubblica fin dalla sua nascita per il nome altamente improbabile scelto da Musk e dalla madre, la musicista Grimes [3].
Durante la conferenza stampa, Musk ha deliberatamente permesso al piccolo di muoversi liberamente nella Sala Ovale, infrangendo ogni protocollo formale. X Æ A-Xii ha interrotto più volte la conferenza con smorfie e commenti infantili, mentre Musk, anziché frenarlo, sembrava divertirsi e incoraggiare l’interazione. Questo comportamento, per nulla casuale, è facilmente leggibile come una sfida aperta alle convenzioni istituzionali: l’imprenditore più ricco del mondo stava mettendo in scena un gioco di potere dentro la stanza simbolicamente più potente della politica americana [4].
L’episodio ha suscitato reazioni contrastanti. Alcuni hanno trovato la scena divertente e informale, altri l’hanno interpretata come un ulteriore atto di ridicolizzazione delle istituzioni da parte di Musk. Grimes, madre del bambino, ha espresso il proprio disappunto per l’uso mediatico del figlio senza il suo consenso, sollevando anche una questione sulla privacy e sull’educazione dei bambini nelle famiglie iper-esposte ai media (People, 2025).
L’episodio di “Lil X” Musk nella Sala Ovale offre un interessante contrasto con un evento avvenuto nel 2017, che divenne rapidamente virale. Robert Kelly, politologo britannico ed esperto di politica asiatica, stava rilasciando un’intervista in diretta per la BBC dalla sua abitazione in Corea del Sud quando i suoi figli irruppero nella stanza. Mentre Kelly discuteva con la giornalista, sua figlia Marion entrò con passo deciso, seguita dal fratellino James in un girello. Pochi secondi dopo, la moglie di Kelly, Jung-a Kim, si precipitò nella stanza nel tentativo di recuperare i bambini, visibilmente in ansia per l’accaduto. L’imbarazzo di Kelly era evidente: cercava di mantenere la compostezza mentre la sua famiglia, in sottofondo, violava il rigido protocollo della diretta televisiva. L’espressione di sua moglie, evidentemente costernata, suggeriva un senso di vergogna ancora più marcato, probabilmente amplificato dalla appartenenza ad una cultura, quella coreana, che attribuisce grande importanza all’autocontrollo e alla professionalità in contesti pubblici. L’episodio divenne immediatamente virale, generando soprattutto ilarità e simpatia. Kelly fu poi invitato in varie trasmissioni a commentare l’accaduto, e lui stesso riconobbe che la reazione sproporzionata della moglie derivava da una sensibilità culturale diversa. Il tutto si risolse con un’ondata di affetto per la famiglia e con un’autoironia che contribuì a smorzare il momento di imbarazzo (The Guardian, 2017).
Se nel caso di Kelly la violazione del protocollo fu accidentale e immediatamente percepita come un errore, nel caso di Musk la scelta di portare X Æ A-Xii alla Casa Bianca è stata chiaramente deliberata e strategica. Non si è trattato di un semplice gesto informale, quanto piuttosto di una precisa messa in scena del potere. In Dialettica dell’Illuminismo, Adorno e Horkheimer spiegano come la modernità abbia trasformato il simbolismo in strumenti di dominio. L’uso di un bambino per ridicolizzare un’istituzione come la Presidenza degli Stati Uniti è una perfetta rappresentazione della logica dello spettacolo di potere tipica del capitalismo avanzato[5]. Se l’élite politica un tempo si imponeva attraverso il rispetto delle forme e dei rituali istituzionali, oggi il potere economico ha la capacità di sovvertire quei riti, deridendo le regole e imponendo la propria narrazione mediatica.
L’irruzione del piccolo X Æ A-Xii non è stato quindi un semplice episodio familiare, come può essere considerato quello di Kelly, ma un atto performativo che voleva sottolineare come il dominio oggi si eserciti anche attraverso la rottura delle regole. In questa prospettiva, Musk non ha solo mostrato la propria influenza sulla Casa Bianca, ma ha anche affermato che il vero potere non risiede tanto nelle istituzioni politiche, quanto nella capacità di manipolare il discorso pubblico e ridefinire la realtà attraverso la narrazione e i media.
In definitiva, mentre Kelly e la moglie hanno vissuto il loro incidente come una temporanea perdita di controllo, Musk ha trasformato un gesto analogo in uno strumento di dominio, ribadendo come, nell’epoca del capitalismo digitale, il potere più grande sia quello di controllare il simbolico, ridefinire i protocolli e, se necessario, ridicolizzarli per mostrare di esserne addirittura al di sopra.
Il dominio della mente: la psicopolitica nell’era neoliberale
Gli eventi che abbiamo fin qui raccontato evidenziano una dinamica sicuramente complessa tra potere politico ed economico. Trump, con la sua posizione politica, e Musk, con la sua immensa ricchezza, sembrano impegnati in una competizione, un testa a testa volto a dimostrare chi possieda un’influenza maggiore sulla società e sulle istituzioni. Le loro azioni – dal rebranding di marchi consolidati, alla ridefinizione di nomi geografici storici, fino alla deliberata trasgressione di regole che essi stessi dovrebbero garantire – non rappresentano semplici provocazioni, ma veri e propri atti performativi di potere. Non si tratta di sfide alle convenzioni, bensì di dimostrazioni di un dominio che si esercita proprio attraverso la loro sovversione spettacolarizzata.
Il potere moderno non si manifesta solo nell’imposizione di norme, ma anche nella capacità di infrangerle senza conseguenze, trasformando questa trasgressione in uno strumento di affermazione. Come suggerivano già Horkheimer e Adorno 80 anni fa, l’industria culturale gioca un ruolo centrale in questo processo, perché trasforma la violazione stessa in evento mediatico, normalizzandola e rendendola parte del ciclo dell’intrattenimento.
I potenti di oggi non stanno soltanto ridefinendo la realtà attraverso il linguaggio, ma stanno soprattutto mostrando che la realtà stessa è plasmabile dal loro potere, perché non vi sono regole che essi non possano riscrivere o violare a proprio vantaggio. La loro capacità di trasgredire senza conseguenze è essa stessa una forma di dominio, un modo per rafforzare la percezione della loro eccezionalità. Il potere moderno non ha più bisogno di imporsi attraverso la forza diretta: può permettersi di farsi gioco delle regole e piegarle al proprio spettacolo.
Questa trasformazione del potere è profonda, è quello che Byung-Chul Han definisce come il passaggio dalla biopolitica alla psicopolitica: il controllo della società non avviene più attraverso la coercizione diretta, bensì attraverso la gestione delle emozioni, dei desideri e della percezione della realtà (Han, 2016). Il neoliberismo psicopolitico crea individui che non devono più essere costretti a comportarsi in un certo modo: sono essi stessi a desiderare ciò che il sistema vuole da loro. Chi detiene oggi il potere non governa attraverso la forza, ma attraverso la narrazione, plasmando la realtà in modo che le decisioni e gli atti simbolici appaiano come naturali e inevitabili. La psicopolitica è il meccanismo che permette ai potenti di ridefinire le convenzioni senza incontrare resistenza, perché operano direttamente sulle strutture del pensiero e del desiderio collettivo.
Il Panottico digitale: come la libertà diventa controllo
Byung-Chul Han, nel suo testo Psicopolitica del 2016, sottolinea come il potere non si imponga più dall’alto, ma funzioni attraverso la partecipazione volontaria. Secondo lui, i social media sono il cuore di questa trasformazione: gli utenti credono di essere liberi, ma in realtà alimentano un sistema che raccoglie dati, analizza comportamenti e influenza decisioni senza che vi sia bisogno di un’imposizione esplicita. La psicopolitica digitale è più efficace della biopolitica disciplinare descritta da Foucault, perché anziché costringere gli individui, li guida dolcemente a conformarsi ai dettami del sistema.
“Il potere intelligente, dall’aspetto liberale, benevolo, che invoglia e seduce, è più efficace del potere che ordina, minaccia e prescrive. Il like è il suo segno: mentre consumiamo e comunichiamo, anzi mentre clicchiamo like, ci sottomettiamo al rapporto di dominio.”(Han, 2016, p. 25)
Non a caso chi detiene il potere economico ha deciso di diventare leader anche nel settore dei social media e (per ora senza grandi successi) anche in quello della cosiddetta intelligenza artificiale: attraverso la penetrazione dei social media, non c’è bisogno di imporre regole dall’alto, perché la piattaforma stessa orienta la conversazione pubblica in base agli algoritmi e ai modelli predittivi. Gli utenti non vengono censurati direttamente (anzi, il passaggio da Twitter a X è stato presentato tra le altre cose come un grandioso rilancio della libertà di parola), ma il flusso di informazioni è sottilmente manipolato in modo tale da favorire certi contenuti e oscurarne altri (Timm, 2024).
Questo meccanismo favorisce ciò che Han chiama auto-sorveglianza volontaria: nel capitalismo digitale non ci sono più soggetti oppressi e oppressori chiaramente identificabili, perché il controllo avviene attraverso una sorveglianza digitale di noi stessi. Gli individui interiorizzano le dinamiche del sistema e diventano complici della propria sottomissione.
“Il potere intelligente si plasma sulla psiche, invece di disciplinarla o di sottoporla a obblighi o divieti. Non ci impone alcun silenzio. Piuttosto, ci invita di continuo a comunicare, a condividere, a partecipare, a esprimere le nostre opinioni, i nostri bisogni, desideri o preferenze, e a raccontare la nostra vita. Questo potere intelligente è, per così dire, più potente del potere repressivo. Si sottrae a ogni visibilità.” (Han, 2016, p. 25)
È probabilmente in questa ottica che i potenti della società digitale neoliberale riescono a violare le regole senza generare una vera opposizione. Fino a non molto tempo fa, le continue trasgressioni dei protocolli sarebbero state lette come abusi di potere; oggi, invece, vengono percepite (e addirittura esaltate) come gesti di autenticità e carisma. La psicopolitica produce leader che non si impongono con la forza, ma con la capacità di orientare le emozioni collettive.
Non è più necessario un potere repressivo tradizionale: basta controllare il linguaggio, le emozioni e la percezione pubblica per ottenere un dominio totale senza resistenza.
Nella società della connessione continua, il potere non vieta, ma seduce; non reprime, ma persuade; non impone, ma si fa desiderare. Il vero potere non si manifesta più nella capacità di comandare, ma nella capacità di rendere il dominio invisibile.
I social media in particolare hanno trasformato il panorama dell’informazione, creando ambienti in cui gli utenti tendono a interagire principalmente con individui che condividono le loro stesse opinioni. Piattaforme come X o Facebook utilizzano algoritmi che promuovono contenuti in linea con le preferenze degli utenti, limitando l’esposizione a opinioni divergenti. Questo isolamento informativo facilita la creazione di bolle digitali dette “echo chambers”, nelle quali le convinzioni vengono polarizzate e continuamente rafforzate senza un reale confronto (Cinelli et al., 2021), essendo inoltre facilmente strumentalizzabili per fini politici. È noto ad esempio che durante le ultime elezioni presidenziali statunitensi del 2024, influencer su piattaforme come Twitch e YouTube hanno mobilitato i loro vasti seguaci per votare, trasformando l’evento in quella che è stata definita una “elezione degli influencer” (Watercutter, 2025).
Per mezzo di questa strategia le comunità online possono essere facilmente orientate (politicamente, ma non solo) attraverso contenuti mirati, sfruttando la natura chiusa delle loro reti. Nell’ambito di queste bolle, il concetto stesso di verità diventa fluido: la diffusione di informazioni non verificate o false può prosperare, poiché gli utenti tendono a fidarsi delle fonti che confermano le loro convinzioni. Nessun debunking è più possibile perché ci stiamo sempre più addentrando nell’era della post-verità (Keyes, 2024). Questo fenomeno è stato recentemente amplificato dalla decisione di piattaforme come Meta (che include Facebook e Instagram) di eliminare i programmi di fact-checking, sostituendoli con sistemi di “note della comunità” (Gibson, 2025), una mossa che echeggia quella messa in atto da Musk nel passaggio da Twitter a X e pubblicizzata come un passo verso la libertà di espressione. La rimozione dei fact-checker professionali in favore di sistemi guidati dalla comunità ha sollevato preoccupazioni riguardo alla proliferazione di disinformazione e hate speech e può portare a una maggiore diffusione di informazioni errate, mancando un filtro esperto per valutare l’accuratezza dei contenuti (Körömi, Haek and Cheslow, 2025).
La responsabilità di discernere la verità ricade sempre più sui singoli utenti, che però difficilmente riescono a farlo, data la scarsa alfabetizzazione mediatica e la mancanza di strumenti comunitari efficaci per combattere il diffondersi della disinformazione.
Autocontrollo e autodistruzione: il Panottico digitale
In un quadro come questo, la psicopolitica è riuscita dunque a fare in modo che il soggetto neoliberale si controllasse e si disciplinasse da solo, generando una dinamica distruttiva che, invece di portare all’emancipazione, conduce all’esaurimento e all’autodistruzione.
A questo proposito, Han richiama l’immagine del Panopticon descritto da Bentham che serviva a disciplinare i corpi attraverso la minaccia della sorveglianza; il moderno panottico digitale rappresenta secondo l’autore coreano una evoluzione sofisticata e più subdola del controllo sociale. Jeremy Bentham aveva infatti progettato una prigione ideale in cui i detenuti fossero osservabili in ogni momento da una torre centrale, senza poter vedere l’osservatore. Questo dispositivo di sorveglianza unidirezionale non richiedeva una presenza costante del guardiano: era sufficiente che il detenuto si percepisse sempre potenzialmente osservato affinché si autoconformasse alle regole (Bentham, 1791). Michel Foucault ha ripreso questa idea nel secolo scorso, evidenziando come il Panopticon non fosse solo un modello carcerario, ma la metafora di una società disciplinare in cui il potere si esercita attraverso la sorveglianza, la norma e il controllo sistematico del comportamento (Foucault, 1975).
Tuttavia, come sottolinea Han, la società neoliberale ha prodotto un cambiamento radicale nel funzionamento del potere. Se nella visione foucaultiana la disciplina si imponeva con divieti, obblighi e sanzioni, oggi il controllo si esercita attraverso la seduzione, la partecipazione volontaria e l’illusione della libertà. Il panottico digitale non è più una prigione visibile con un guardiano centrale, ma una rete distribuita in cui ciascuno non solo è osservato, ma contribuisce attivamente alla propria sorveglianza. Non c’è più bisogno di una torre centrale perché siamo noi stessi a fornire i dati necessari per il nostro controllo: ogni azione, ogni ricerca online, ogni interazione sui social network viene registrata, analizzata e utilizzata per prevedere e influenzare il comportamento delle masse.
Questo passaggio rappresenta il cuore della evoluzione dalla biopolitica alla psicopolitica. Se la biopolitica, come teorizzata da Foucault, mirava a disciplinare i corpi attraverso istituzioni come la scuola, la caserma, l’ospedale o la prigione, la psicopolitica agisce direttamente sulla mente, sulle emozioni e sui desideri. Il potere non impone più regole dall’esterno, ma si insinua all’interno dell’individuo, inducendolo a conformarsi spontaneamente. I soggetti non si sentono oppressi, bensì incentivati a esprimersi, a comunicare e a condividere continuamente, credendo di esercitare una libertà che in realtà è funzionale al sistema di controllo.
Questo meccanismo porta a un paradosso: mentre il panottico tradizionale era basato sulla paura della sorveglianza, il panottico digitale si fonda sul desiderio di visibilità. Non ci sentiamo affatto costretti a rivelare le nostre informazioni personali, al contrario lo facciamo volontariamente, perché viviamo questa occasione come un’opportunità. Condividiamo tranquillamente dettagli della nostra vita, accettiamo di essere tracciati, permettiamo agli algoritmi di analizzare ogni nostra abitudine di consumo, spesso senza renderci conto che questi stessi dati possono venire usati per manipolare le scelte e influenzare il comportamento di gruppi di persone con caratteristiche simili a noi.
Foucault parlava di disciplinamento, Han sostiene che oggi non è più necessario imporre disciplina perché il sistema ha trovato un modo più efficace per ottenere lo stesso risultato: ci porta a volerci disciplinare da soli. Il soggetto neoliberale non è più un prigioniero che teme il guardiano, ma un individuo che si auto-sorveglia, si auto-ottimizza, si auto-esibisce, credendo di esercitare la propria libertà mentre, in realtà, si sottomette al dominio del sistema.
Questa dinamica era stata perfettamente anticipata da Horkheimer e Adorno quando affermavano:
Con lo sviluppo del sistema economico in cui il dominio di gruppi privati sull’apparato produttivo divide e separa gli uomini, l’autoconservazione data come identica dalla ragione, l’istinto oggettivato dell’individuo borghese, si rivelò come forza naturale distruttiva, inseparabile dall’autodistruzione. L’una trapassò confusamente nell’altra. (Horkheimer and Adorno, 1947, p. 96)
L’autoconservazione è diventata autodistruzione: il soggetto neoliberale, nella sua incessante ricerca di ottimizzazione, finisce per esaurire sé stesso, trasformandosi in un ingranaggio di un sistema che lo consuma senza offrirgli alcun orizzonte di senso. Il panottico digitale è quindi una prigione senza sbarre, nella quale la libertà stessa è trasformata in un dispositivo di controllo: più pensiamo di essere liberi di esprimerci, più forniamo dati utili per modellare e dirigere i nostri comportamenti.
Secondo Han, la società della trasparenza e dell’ipercomunicazione non produce soggetti emancipati, ma individui sempre più fragili, esposti e controllabili. Nella sua prospettiva, la libertà non è più un diritto da conquistare, ma una trappola in cui il soggetto è spinto a correre senza sosta, convinto di essere autonomo mentre, in realtà, segue traiettorie già scritte da logiche algoritmiche e interessi economici.
Libertà senza scopo: il cortocircuito della psicopolitica
La libertà, quindi, nell’era della società digitale neoliberale sembra essere intrappolata in un cortocircuito. I suoi confini si sono sfumati, le sue declinazioni sono state ridefinite, e il suo significato sembra oscillare tra concessione illusoria e dominio incontrastato. Il sistema in cui siamo immersi, con i suoi strumenti informatici, le sue reti sociali e le sue promesse di connessione illimitata, offre ai cittadini—o meglio, agli utenti—una versione rudimentale di quella che viene chiamata libertà positiva: la sensazione di poter fare cose che prima non erano accessibili, di essere “liberi di” agire in modi nuovi. Questa concessione, tuttavia, non è che un’illusione calibrata. È un assaggio fugace di libertà, costruito sul piano delle emozioni, un inganno che spinge l’individuo a percepirsi come protagonista, quando in realtà è sempre più vincolato da logiche algoritmiche, da meccanismi di sorveglianza invisibile e da schemi di condizionamento psicopolitico.
Dall’altra parte della scena si muovono i veri detentori del potere, coloro che governano questa realtà digitale: essi non si accontentano della libertà concessa, ma detengono quella che viene definita libertà negativa, la “libertà da”, ovvero l’assenza effettiva di vincoli e costrizioni. È in questo caso quasi una libertà assoluta, che non si limita all’azione, ma si estende alla possibilità di sottrarsi a ogni norma, di muoversi al di fuori delle restrizioni che invece imbrigliano il cittadino comune. Non è solo il potere di fare, ma soprattutto il potere di non essere vincolati, né da regole istituzionali, né da codici morali, né da convenzioni sociali o culturali.
Eppure, in entrambe queste dimensioni della libertà — quella concessa all’individuo e quella detenuta dai nuovi sovrani della psicopolitica — sembra mancare qualcosa di essenziale: la “libertà per”. Ogni esercizio di libertà dovrebbe avere un fine, un τέλος, un orizzonte verso cui orientarsi. Ma quale sarebbe oggi lo scopo ultimo di queste libertà?
A quale fine viene esercitata la piccola libertà quotidiana dell’utente digitale, immerso in un flusso perenne di emozioni condivise nel panottico dei social media?
E quale orizzonte giustifica l’ostentazione delle libertà illimitate dei nuovi oligarchi del capitale e della comunicazione, che trasformano ogni gesto in una dimostrazione di potere?
Lo spettacolo della psicopolitica contemporanea appare come un teatro caotico, nel quale gli attori si accalcano sulla scena, cercando di imporsi l’uno sull’altro, senza che sia chiaro quale sia la trama, il senso ultimo di questa rappresentazione. Se il linguaggio è stato svuotato e trasformato in uno strumento di dominio, così anche la libertà è diventata una merce priva di scopo, un ingranaggio che si muove per inerzia dentro un sistema che ormai sembra aver perso il suo orizzonte. Siamo addirittura oltre alla libertà del girarrosto evocata da Kant[6].
Ciò che resta, come unico filo conduttore, è l’esercizio del potere. L’Illuminismo, con la sua razionalizzazione del mondo, aveva promesso emancipazione, ma ha finito per costruire nuove forme di dominio, più subdole e pervasivamente interiorizzate. Oggi la libertà stessa è piegata a questa logica: diventa un mezzo per rafforzare i meccanismi di autodisciplina, un paradosso in cui la libertà individuale è resa funzionale al potere, mentre il potere si affranca da qualsiasi regola. In ultima analisi, non è forse questo il vero codice genetico dell’Illuminismo, per come ce lo hanno mostrato Horkheimer e Adorno? La promessa della ragione che si trasforma in razionalità calcolatrice per esercitare il controllo, la liberazione che si rovescia in autodominio e, alla fine del percorso, persino la libertà, invece di affrancare, diventa un ulteriore strumento di assoggettamento.
Bibliografia
Adorno, T.W. (1954) Minima moralia. Einaudi.
Aistė Jočytė (2024) One year later: Why 89% of brands still call it Twitter despite the rebrand to X, Omnisend Blog. Available at: https://www.omnisend.com/blog/why-brands-still-call-it-twitter/ (Accessed: 19 February 2025).
Andersen, H.C. (1837) Il re nudo. 2019th edn. Translated by D.I. Murgia. TopiPittori. Available at: https://books.google.it/books?id=aeXSyQEACAAJ.
ANSA (2025) ‘Google Maps rinomina in USA Golfo del Messico in Golfo d’America’. Available at: https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/01/28/google-maps-rinomina-in-usa-golfo-del-messico-in-golfo-damerica_6c66635e-9c8c-410a-99d5-247651018d9b.html.
Bentham, J. (1791) Panopticon Or the Inspection House. T. Payne (Panopticon Or the Inspection House, v. 1). Available at: https://books.google.it/books?id=Ec4TAAAAQAAJ.
Cinelli, M. et al. (2021) ‘The echo chamber effect on social media’, Proceedings of the National Academy of Sciences, 118(9), p. e2023301118. Available at: https://doi.org/10.1073/pnas.2023301118.
El País (2025a) ‘De Golfo de México a Golfo de América: Trump renombra el mapa aunque con improbables consecuencias internacionales’. Available at: https://elpais.com/us/2025-01-21/de-golfo-de-mexico-a-golfo-de-america-trump-renombra-el-mapa-aunque-con-improbables-consecuencias-internacionales.html.
El País (2025b) ‘Trump veta indefinidamente a AP por escribir “Golfo de México” en sus informaciones’. Available at: https://elpais.com/internacional/2025-02-14/trump-veta-indefinidamente-a-ap-por-escribir-golfo-de-mexico-en-sus-informaciones.html.
Forbes (2025) ‘Elon Musk’, Forbes. Available at: https://www.forbes.com/profile/elon-musk/ (Accessed: 19 February 2025).
Foucault, M. (1975) Sorvegliare e punire. Nascita della prigione. 2005th edn. Translated by A. Tarchetti. Einaudi (ET. Saggi). Available at: https://books.google.it/books?id=psfwPAAACAAJ.
Geopop (2025) ‘Apple Maps rinomina il Golfo del Messico in Golfo d’America sulla scia di Google Maps’. Available at: https://www.geopop.it/apple-maps-rinomina-il-golfo-del-messico-in-golfo-damerica-sulla-scia-di-google-maps/.
Gibson, K. (2025) Meta to end fact-checking, replacing it with community-driven system akin to Elon Musk’s X – CBS News. Available at: https://www.cbsnews.com/news/meta-facebook-instagram-fact-checking-mark-zuckerberg/ (Accessed: 22 February 2025).
Glamour (2025) ‘Grimes and Elon Musk: Their Upsetting Online Conflict, Explained’. Available at: https://www.glamour.com/story/grimes-and-elon-musk-their-upsetting-online-conflict-explained.
Goodwin, G.E. (2025) ‘Gulf of Mexico, or Gulf of America? Trump makes a call, but who follows?’, Business Insider. Available at: https://www.businessinsider.com/trump-renaming-gulf-mexico-google-implications-2025-1 (Accessed: 19 February 2025).
Han, B.-C. (2016) Psicopolitica. Il neoliberismo e le nuove tecniche del potere. Nottetempo.
Horkheimer, M. and Adorno, T.W. (1947) Dialettica dell’illuminismo. Translated by R. Solmi.
Kant, I. (1788) Critica della ragion pratica. 2019th edn. Edited by F. Capra and S. Landucci. Translated by E. Garin. Editori Laterza. Available at: https://books.google.it/books?id=4oqxDwAAQBAJ.
Keyes, R. (2024) The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life. St. Martin’s Press. Available at: https://books.google.it/books?id=f0Kvm3KObXoC.
Kinnard, M. (2025) ‘White House says it’s a “fact” the Gulf of Mexico has been renamed. Is that right?’, The Independent, 13 February. Available at: https://www.independent.co.uk/news/world/americas/donald-trump-white-house-karoline-leavitt-north-america-claudia-sheinbaum-b2697690.html (Accessed: 22 February 2025).
Körömi, C., Haek, P. and Cheslow, D. (2025) ‘Zuck goes full Musk, dumps Facebook fact-checking program’, Politico. Available at: https://www.politico.eu/article/mark-zuckerberg-full-elon-musk-dump-facebook-fact-checker/?utm_source=chatgpt.com (Accessed: 22 February 2025).
Matthews, F.S., David Wright, Alex Leeds (2024) ‘Musk spent at least a quarter-billion dollars to help elect Donald Trump, new filings show | CNN Politics’, CNN, 6 December. Available at: https://www.cnn.com/2024/12/05/politics/elon-musk-trump-campaign-finance-filings/index.html (Accessed: 19 February 2025).
Sky News (2025) ‘Trump “offended” by Zelenskyy not wearing a suit in White House’, Sky News. Available at: https://news.sky.com/story/trump-offended-by-zelenskyy-not-wearing-a-suit-in-white-house-13319114 (Accessed: 2 March 2025).
Timm, T. (2024) ‘Elon Musk has become the world’s biggest hypocrite on free speech’, The Guardian, 15 January. Available at: https://www.theguardian.com/commentisfree/2024/jan/15/elon-musk-hypocrite-free-speech (Accessed: 20 February 2025).
Watercutter, A. (2025) ‘In 2024, Fandom Conquered the World’, Wired. Available at: https://www.wired.com/story/the-year-fandom-conquered-the-world/ (Accessed: 22 February 2025).
Wikipedia (2023) ‘Twitter under Elon Musk’, Wikipedia. Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Twitter_under_Elon_Musk.
Wikipedia (2025) ‘Musk family’, Wikipedia. Available at: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Musk_family&oldid=1276543007 (Accessed: 19 February 2025).
Note
[1] E in effetti il cambiamento è stato solo parzialmente efficace: un po’ per abitudine, un po’ per fastidio, un po’ per ripicca, la grande maggioranza degli utenti di X continuano a chiamarlo imperterriti “Twitter”, nonostante la seccatura del suo proprietario (Aistė Jočytė, 2024).
[2] Nessuno in effetti ha capito che senso abbia questa operazione, né lui, né qualcuno del suo staff è riuscito – o ha voluto – spiegarlo in qualche modo: “da oggi si chiama così e basta, è un fatto” (Kinnard, 2025).
[3] Inizialmente, i genitori avevano scelto il nome “X Æ A-12”, ma hanno dovuto modificarlo in “X Æ A-Xii” per conformarsi alle leggi californiane che vietano l’uso di numeri arabi nei nomi propri (Wikipedia, 2025). Anche questa è una violazione dei protocolli, un anticonformismo apparente, che nasconde in realtà la volontà di esercitare un potere – ancora una volta tramite il linguaggio – sul sistema, distinguendosi soprattutto dai comuni cittadini, cui non è consentito usare nomi tanto eccentrici. Il nome “X Æ A-Xii” non è soltanto una scelta bizzarra o un capriccio personale, ma rappresenta anche un atto performativo che esprime un preciso messaggio di dominio con cui Musk, come altri esponenti del potere economico, si pone al di sopra delle norme che regolano la vita quotidiana degli individui comuni.
[4] Dopo il completamento di questo articolo si è verificato un evento analogo che merita di essere descritto. Il 28 febbraio 2025, durante un incontro alla Casa Bianca con il presidente Trump e il vicepresidente J.D. Vance, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy è stato oggetto di pesanti critiche per il suo abbigliamento. Zelenskyy indossava la consueta uniforme militare che porta dall’inizio dell’invasione russa, simbolo di resistenza e unità nazionale, tuttavia, è stato accolto da Trump con un commento sarcastico: «Si è vestito elegante oggi», come se si trattasse di un ospite qualunque malvestito, piuttosto che del leader di un Paese in guerra. Poco dopo, in diretta mondiale, il giornalista Brian Glenn ha incalzato Zelenskyy con una delle tante domande surreali di quell’incontro: «Perché non indossi un completo? Ti trovi nell’ufficio più importante di questo Paese e ti rifiuti di indossarne uno. Possiedi un completo?». La provocazione ha suscitato le risate dei presenti, incluso il vicepresidente Vance. A riprova che non si è trattato di una casualità né di un dettaglio trascurabile, la presunta “mancanza di rispetto” di Zelenskyy è stata immediatamente trasformata in un caso mediatico dalla stampa filo-trumpiana e da numerosi politici conservatori. Sui social media è stata lanciata una campagna-lampo che ha raggiunto milioni di visualizzazioni e interazioni, dipingendo l’abbigliamento del presidente ucraino come un affronto deliberato alle istituzioni statunitensi (Sky News, 2025). Esattamente come nel caso della conferenza di Musk, ma in una forma specularmente opposta, anche in questa situazione il codice dell’abbigliamento è stato strumentalizzato per rafforzare una precisa gerarchia di potere. Le critiche all’uniforme di Zelenskyy hanno assolto una duplice funzione: da un lato hanno screditato un ex alleato per minarne la credibilità agli occhi dell’opinione pubblica; dall’altro (anche se in questo caso implicitamente e secondariamente) hanno ribadito l’aura di potere che circonda Elon Musk, per il quale t-shirt e cappellino erano invece stati considerati perfettamente adeguati solo un paio di settimane prima. Mentre persino il capo di stato di un Paese in guerra, teoricamente alleato degli USA, deve attenersi rigidamente alle regole del decoro, pena l’esposizione al pubblico ludibrio dell’industria culturale e della macchina mediatica dei social network, chi detiene il potere politico ed economico e quei media e quei social network li possiede e li controlla, si conferma saldamente al di sopra delle convenzioni.
[5] Impossibile non pensare alla fiaba “I vestiti nuovi dell’imperatore” di Hans Christian Andersen nella quale è proprio un bambino, con la sua innocenza e la sua incapacità di conformarsi alla menzogna collettiva, a rivelare la nudità del potere (Andersen, 1837). Tuttavia, mentre nella fiaba l’esclamazione del bambino spezza l’illusione e apre uno spiraglio di verità, nella logica dello spettacolo contemporaneo l’effetto è paradossale: l’atto di svelamento diventa esso stesso parte del meccanismo. Il potere, lungi dall’essere messo in crisi, si alimenta della propria messa in scena, inglobando anche la derisione e la critica all’interno del proprio ciclo autoreferenziale e trasformando persino la figura di un bambino in uno strumento di legittimazione del sistema di dominio.
[6] Immanuel Kant utilizza l’immagine del girarrosto nella Critica della Ragion Pratica per illustrare una libertà apparente: il girarrosto, una volta caricato, si muove “autonomamente”, ma la sua azione è interamente determinata dal meccanismo che lo anima (Kant, 1788, p. 119). La libertà autentica non è semplicemente la capacità di compiere azioni apparentemente volontarie, ma consiste nella possibilità di iniziare una nuova serie causale, di agire in modo spontaneo e non determinato da leggi meccaniche o necessità esterne.